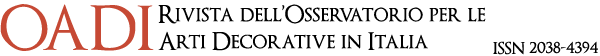m.becattini@museostibbert.it
La lacca giapponese: l’equipaggiamento del samurai nelle collezioni del Museo Stibbert
DOI: 10.7431/RIV15072017
Le opere in lacca1 destinate alla classe militare costituiscono fin dall’antichità un aspetto importante dell’identità sociale e culturale del samurai, un vero e proprio patrimonio di rappresentanza (omote-dōgu).
Da sempre simbolo dell’importanza e del potere di chi lo possiede, questo pregiato materiale era stato impiegato per più di cinquecento anni esclusivamente per la decorazione di templi e per la realizzazione di statue buddhiste, oppure aveva rivestito le suppellettili destinate alla famiglia imperiale e alla ristretta cerchia della nobiltà di corte. Quando a partire dall’epoca Kamakura (1185-1333) i clan guerrieri si avvicendano al potere, relegando l’imperatore ad una funzione solo nominale, le lacche divengono l’emblema di questa nuova classe dirigente e dei conseguenti rivolgimenti sociali.
Le opere in lacca acquistano una forza e uno splendore che modificano radicalmente quest’arte per accordarla al gusto dei samurai, che vogliono opere funzionali, leggere e dalle dimensioni contenute, ma allo stesso tempo raffinate ed eleganti. In epoca Kamakura le preferenze della classe militare vanno alle linee possenti, ai forti contrasti di colore e alle superfici che simulano l’aspetto del metallo massiccio, grazie all’impiego delle polveri d’oro.
Tuttavia le pressoché illimitate possibilità espressive di questo materiale permettono la nascita di forme ornamentali sempre differenti, che vengono nel tempo arricchite di innovazioni e adattate al gusto dei clan al potere. Per tutto il periodo feudale (1185 – 1867) l’equipaggiamento in lacca dei samurai assumerà una funzione simbolica, dovendo rappresentare il loro prestigio, la potenza e la ricchezza. Il potere e l’importanza del casato di appartenenza possono essere infatti facilmente compresi osservando l’antichità, la qualità ed il pregio dei finimenti del guerriero, sui quali compaiono anche i principali stemmi di famiglia, riconosciuti e registrati dall’amministrazione shōgunale.
I daimyō (feudatari), obbligati a mantenere la residenza a Edo ed a recarvisi ad anni alterni, dovevano sostenere folli spese di rappresentanza per pagare i frequenti spostamenti dal proprio feudo alla capitale shōgunale e viceversa. Lunghe processioni (daimyō gyōretsu) di guerrieri a cavallo, samurai appiedati, vessilliferi, inservienti e portatori, con bagagli in lacca della migliore qualità, accompagnavano i propri daimyō attraverso il Giappone, offrendo un pubblico spettacolo della loro posizione di uomini di regime in seno all’apparato shōgunale. Questi continui spostamenti e le spese enormi avevano anche l’effetto di defatigare e impoverire i feudatari, che di fatto mancavano dei mezzi necessari e del tempo per organizzare attività sovversive.
Di queste opere di rappresentanza il Museo Stibbert di Firenze possiede una ricchissima collezione, acquisita da Frederick Stibbert negli ultimi tre decenni dell’Ottocento, quando dopo quasi due secoli di isolamento il Giappone riapriva le sue frontiere all’Occidente, riversando sul mercato una produzione artistica di altissimo livello e del tutto innovativa agli occhi degli europei.
Una collezione, quella giapponese, principalmente composta di armi e armature, ma che comprende anche opere per così dire “gentili”, come suppellettili in lacca, bronzo, porcellana, tessuti, acquistati da Stibbert presso gli antiquari ed i negozianti italiani, francesi ed inglesi.
In lacca sono realizzate le decorazioni di molteplici opere dell’equipaggiamento del samurai, dai foderi e gli astucci per le spade, alle faretre, i cappelli da guerra, le selle. Fra questi prenderemo in esame un primo gruppo di opere accomunate dalla medesima tecnica decorativa, il raden (termine giapponese per il cinese luodian) ovvero madreperla incrostata e laccata, una tecnica nata in Cina nel corso dell’epoca Tang2 e sviluppatasi in Giappone durante il periodo Nara (646-794), quando, grazie ai più intensi rapporti stabiliti con il continente, vengono facilitati quei fruttuosi scambi culturali che porteranno alla fioritura di una letteratura e di un’arte autoctone giapponesi. Le incrostazioni di madreperla o altre pietre dure, sviluppatesi in questi anni, conosceranno grande diffusione nei secoli successivi.
Per primo consideriamo l’opera n. 8090 delle collezioni Stibbert, una sella da cavallo (kura) decorata con la tecnica del raden (Fig. 1). La sella estremo-orientale, sia per uso cerimoniale in stile cinese (karakura), pesante ed elaborata nell’ornamentazione, sia destinata al campo di battaglia, di tipo giapponese (gunjingura), leggera e comoda, è un capolavoro di carpenteria specializzata, i cui procedimenti di lavorazione vengono custoditi gelosamente e tramandati di padre in figlio. Composta di quattro pezzi ben sagomati in legno, tenuti insieme da corde, due arcioni molto arcuati e due parti che compongono la seduta, la struttura della sella giapponese risulta molto elastica e resistente agli urti. La sua particolare conformazione permette al cavaliere di alzarsi in piedi sulle staffe, stringendo la sella con le gambe, e di scagliare frecce o sguainare la spada. Le superfici delle varie parti si prestano poi ad un repertorio pressoché inesauribile di motivi decorativi.
Una sella ben fatta è quindi frutto di un lavoro altamente specializzato; per questo i maestri più grandi firmano le opere con il proprio sigillo (kao) e vi appongono la data di fattura.
È facile comprendere come un’opera di tale valore venga custodita nei secoli quale tesoro di famiglia e come possa, se danneggiata dall’usura, essere nel tempo restaurata, riparando i rivestimenti e i decori, o addirittura venire anche completamente rilaccata.
La sella in esame è firmata da Sadayasu e Masatomo e risulta di datazione incerta. I dubbi nascono dal fatto che la firma su questa opera è in lacca rossa, tratto distintivo in Giappone per indicare un’attribuzione apocrifa. In particolare, la scarsità di notizie sulle figure dei due maestri ha in un primo tempo fatto collocare la datazione della sella alla prima metà del XVII secolo3. Recenti ricerche hanno fatto nuova luce sulla figura di Sadayasu, permettendo di confermare, su basi anche stilistiche, l’originaria attribuzione e di retrodatare quindi la sella di circa un secolo.
La sella è interamente ricoperta di scaglie di madreperla molto sottili (usugai) di tipo iridescente (aogai mijin), incollate sulla superficie dell’opera e ricoperte da strati successivi di lacca per colmare il dislivello; il tutto è stato poi accuratamente polito, fino a rimettere in vista le tessere. È interessante notare, al fine della datazione dell’opera, che questa tecnica di decorazione è andata quasi completamente scomparendo nel corso dell’epoca Muromachi (1392-1573)4.
Altra caratteristica stilistica che conferma la datazione cinquecentesca è anche l’uso nei bordi dell’aogin, una peculiare tecnica di argentatura (adesso poco leggibile data l’ossidazione).
Sull’arcione anteriore e posteriore, la sella è arricchita da una decorazione in takamaki-e (pittura cosparsa a rilievo) raffigurante karashishi, peculiari cani-leone derivati dalla tradizione cinese (da cui il nome), e fiori di peonia (botan). Sul disegno, modellato a bassorilievo in sabi-urushi (un composto plasmabile di lacca grezza, polvere di cote e acqua), sono state applicate lamine d’oro e argento e polveri cosparse; le nervature e i contorni delle foglie e dei fiori sono stati dipinti con lacca rossa e spruzzati di polvere d’oro.
Il soggetto raffigurato, a dispetto dell’effetto altamente decorativo, richiama tematiche prettamente militari; il karashishi infatti, quale guardiano dei templi buddhisti, è simbolo della forza virile e della perseveranza. Le peonie invece simboleggiano la dignità e l’onore.
Questo tipo di decorazione, che coniuga la tecnica del raden con un leggero takamaki-e, era molto in voga fin dal periodo Kamakura, ed era assai apprezzato dalla classe guerriera.
Alla luce di tali considerazioni siamo propensi a dare credito alla firma che compare sul rovescio della sella: l’artista Sadayasu (1470-1519) risulta infatti attivo almeno dal 1504, anno in cui data e firma con il proprio kao una sella. Egli rappresenta la quinta generazione di una scuola di sellai fondata nella provincia di Ise, in epoca Kamakura, dall’antenato Sadanaga. Questa famiglia tramandava di padre in figlio le tecniche di lavorazione che il fondatore aveva imparato a sua volta dal nonno, il maestro Otsubo (XIII sec.), discendente, si narra, dell’imperatore Kanmu.
Dal punto di vista strutturale la sella è in legno di quercia rossa, una tipologia di legname particolarmente dura e resistente, di un caldo colore rosso sangue, difficile da lavorare per la sua grana nodosa. I fori che compaiono sulla seduta, supporto per un sedile imbottito che oggi non possediamo più, servono per gli staffili. Rovesciando la sella è possibile vedere il rinforzo preparatorio in tela impregnata di lacca, usato per conferire stabilità al supporto ligneo e coesione al rivestimento decorativo.
Dal periodo Momoyama (1568-1603) in poi si conoscono corredi composti da sella e staffe (abumi) con la medesima decorazione. Le staffe giapponesi hanno la forma molto particolare di un “cigno”: il largo predellino, sul quale è possibile poggiare il piede, in punta si curva all’indietro, terminando in corrispondenza del collo del piede in una fibbia rigida per inserire lo staffile. Gli abumi, perlopiù in acciaio, possono anche avere una struttura in legno rivestita di ferro. Il collo della staffa, proprio sotto la fibbia, presenta a volte un decoro a giorno di varie forme, che può indicare la scuola di produzione dell’opera.
Le staffe n. 9848 (Fig. 2), benché presentino, all’interno, la medesima decorazione in raden e, all’esterno, il motivo dei cani-leone e dei fiori di peonia della sella di cui sopra, non fanno parte dello stesso corredo. Questa coppia di abumi riporta sulla parte anteriore del collo la firma dell’autore (Fig. 3), Takeyoshi della città di Kanazawa, nella provincia di Kashū (o Kaga, odierna prefettura di Ishikawa), e risalgono alla seconda metà del periodo Edo (1603-1868). La superficie in acciaio esternamente è decorata con una coppia di karashishi, resi con le tecniche dell’agemina con filo d’argento (ginsen-zōgan) e dell’incrostazione piana in argento (gin-hirazōgan). Nonostante queste staffe siano state realizzate durante i lunghi anni di pace sotto il governo dei Tokugawa, sono opere di alto livello che mantengono ancora saldo il senso virile della tradizione guerriera nel disegno e nei materiali.
Altro elemento dell’equipaggiamento del samurai è la faretra, un’opera che si presta a molteplici possibilità decorative; quella n. 8078 è decorata anch’essa completamente con scaglie di madreperla iridescenti laccate (Fig. 4). La faretra giapponese, ebira, è di forma tubolare rastremata a sezione appena ogivata, con un coperchio ovale piano e bilobato. Si porta sul fianco destro e con la parte affusolata in alto. Le frecce sono conservate con gli impennaggi rivolti verso il basso, e si estraggono aprendo lo sportellino che viene quindi a trovarsi alla base. Questo tipo di faretra può trasportare un set di cinque frecce. La preparazione del supporto ligneo, per la particolare forma di quest’opera, comporta un tipo di lavorazione delicato e preciso; il legno con il quale è costruita deve essere ben stagionato per evitare alterazioni della struttura.
Un mon raffigurante il fiore di kiri (Althea rosata) (Fig. 5), realizzato con fini particelle globulari in oro opaco (kin-fundame) e definito da linee in lacca rossa, poi spruzzate di polvere d’oro di tono più splendente, compare alle due estremità della faretra in posizione speculare; il fiore di kiri può indicare l’appartenenza di quest’opera ad un membro di un clan importante, vicino alla famiglia imperiale.
La faretra può essere sospesa al fianco mediante la fascia in cuoio laccato d’oro che cinge la parte centrale; per impedire l’apertura dello sportellino e la conseguente caduta delle frecce, sono presenti due nastri in seta da annodarsi sopra il coperchio.
Tecnica e stile suggeriscono una datazione dell’opera all’inizio del periodo Edo, ovvero alla prima metà del XVII secolo.
Come copricapo consideriamo invece il jingasa n. 8071 (Fig. 6), il cappello da guerra giapponese (jin significa “militare” e kasa “cappello”), che costituisce l’evoluzione in acciaio, rame o legno, del copricapo conico in paglia tipico dell’Estremo-Oriente. Il jingasa era un elmo aperto destinato ai soldati di fanteria e ai dipendenti dei nobili. L’esemplare del Museo Stibbert appartiene alla tipologia Ichimonji: completamente in legno, di forma rotonda e quasi piatto, viene indossato solo per parate o cerimonie. Non si conosce con esattezza quando il jingasa comincia ad essere utilizzato in Giappone, ma gli esempi più antichi risalgono al XVI secolo; il nostro è di epoca Edo, fra la fine del XVIII sec. e l’inizio del XIX. La superficie esterna, dove compare l’emblema della famiglia daimyō Kyogoku in oro, è completamente rivestita di scaglie iridescenti di madreperla laccate. L’interno è invece laccato di rosso ed è rivestito da una fodera imbottita, da cui scendono due cappi, anch’essi imbottiti, ai quali è possibile attaccare una cordicella per fissare il jingasa sotto il mento.
Di quest’opera nell’archivio del Museo si è anche conservato il documento d’acquisto; identificabile nella descrizione «Round flat-shaped Helmet, dec. with mother-of-pearl N°. 4091», fu acquistato per 5 sterline presso il negozio The Indo China Curio Trading Company, al n. 170 di New Bond Street a Londra, il 22 luglio del 19025. Il jingasa insieme ad altre opere, comprate da Stibbert nella medesima occasione, faceva parte, come si desume dal documento, della collezione Hogdson, probabilmente la raccolta privata dei proprietari della omonima casa d’asta, situata dal 1863 al n. 115 di Chancery Lane, poi incorporata negli anni Sessanta del Novecento nella più famosa ditta Sotheby’s.
Le ultime opere decorate in raden prese in esame sono una coppia di custodie da viaggio per sciabole (katanazutsu) con i numeri d’inventario 7761 e 7762 (Figg. 7 – 8). Questi astucci in legno hanno una forma tubolare incurvata, sensibilmente rastremata alle estremità e si compongono di due parti: coperchio e contenitore; il primo va a calzare perfettamente sulla sponda interna del secondo. Una serratura con chiave assicura ulteriormente l’inviolabilità delle custodie. Durante i lunghi viaggi che conducevano i feudatari dalle province alla capitale, date le ridotte dimensioni della portantina, non era possibile per il samurai tenere le due spade al fianco, che venivano pertanto chiuse entro astucci ed affidate agli uomini del seguito.
La decorazione dei nostri katanazutsu differisce lievemente dalle altre opere in raden che abbiamo esaminato: le scaglie di madreperla iridescente sono infatti di dimensioni quasi puntiformi. La superficie è impreziosita da un motivo in takamaki-e rosso e nero raffigurante libellule e cavallette entro circoli in lacca nera (Fig. 9), ed inoltre farfalle e rane direttamente sul fondo in madreperla. La libellula (akitsu), animale leggero ed aggraziato per antonomasia, è il simbolo stesso del Giappone che viene infatti anche designato come “Isola della Libellula” (Akitsu-shima). Questo appellativo nasce dalla leggenda che vorrebbe il fondatore della dinastia imperiale nipponica, l’essere celeste Jimmu-tennō, aver esclamato mentre osservava il paese dall’alto: “Si direbbe una libellula”. La cavalletta invece in tutto l’Estremo-Oriente incarna l’idea della discendenza numerosa e quindi, per traslato, può essere considerata come simbolo della benedizione divina. La rana (kaeru), che compare soltanto sull’astuccio per katana, mentre quello per wakizashi presenta farfalle, è creduta in Giappone attirare la felicità; si dice che essa ritorni sempre al luogo da dove è partita, infatti il suono kaeru significa anche “ritornare”.
Purtroppo anche per questa coppia di katanazutsu non è possibile conoscere il nome dell’autore ed una datazione esatta; tuttavia il gusto altamente decorativo rimanda ad una datazione tarda: possono essere collocate infatti a metà dell’epoca Edo (XVIII sec.).
In linea generale, si può quindi affermare che la tecnica del raden, sviluppatasi in Giappone già in epoca Nara e quasi completamente scomparsa nel corso dell’epoca Muromachi, viene nuovamente utilizzata nella seconda metà del periodo Edo, esasperandone l’aspetto decorativo: le tessere di madreperla diventano più grandi, per rendere al massimo l’effetto cangiante, e sovente la superficie viene arricchita da rilievi dorati o multicolori.
Il secondo gruppo di opere che andiamo ad esaminare è tipologicamente simile al precedente, ma è caratterizzato da un altro tipo di tecnica decorativa, il takamaki-e, la pittura cosparsa a rilievo. Questo genere di ornamentazione nasce durante il periodo Muromachi (1392-1573), quando gli shōgun della famiglia al potere, gli Ashikaga, favoriscono la diffusione della moda per la pittura cinese ad inchiostro su seta e carta. Per rendere lo stesso effetto sulla lacca, gli artisti giapponesi sviluppano una tecnica ed uno stile completamente nuovi, capaci di simulare al meglio l’effetto pittorico. Il takamaki-e conosce però la massima fioritura durante il periodo Edo, quando l’arte della lacca si diffonde non solo tra l’aristocrazia militare, ma anche fra la borghesia cittadina. I laccatori, per rispondere alle esigenze di una nuova società in fermento, danno vita ad una produzione artistica contraddistinta da una ricca ornamentazione e dalla ricerca di arditezze tecniche. In questo clima anche il takamaki-e raggiunge uno straordinario livello qualitativo per rispondere alle nuove esigenze della classe militare, che ora predilige le lacche sontuosamente decorate in oro. La condizione di pace, la vita nelle città a contatto con mille attrazioni hanno infatti irrimediabilmente mutato la vita dei samurai, che, lontano dai campi di battaglia, conducono un’esistenza del tutto simile a quella dell’emergente classe mercantile (chōnin). L’austerità marziale di ispirazione filosofico-religiosa legata alla dottrina zen viene dai più dimenticata in favore di un’estetica prettamente materialistica.
La sella, decorata in takamaki-e, che prendiamo in esame è la n. 7848 (Fig. 10), strutturalmente simile a quella precedentemente illustrata, ma concepita già in coppia con le staffe, e facente parte di una barda da cavallo completa. Come abbiamo visto, la realizzazione di corredi composti da sella e staffe con la medesima decorazione si afferma dal periodo Momoyama (1568-1603) in poi, e questo concorda con la data di fattura della nostra opera: un giorno di giugno del secondo anno dell’Era Teikyo (1686). Questa sella riporta infatti nella parte sottostante l’anno di esecuzione e la firma dell’autore (Fig. 11). Purtroppo non è stato ancora possibile identificare il kao dell’artista, tuttavia da un’analisi del monogramma si può ipotizzare che si tratti anche in questo caso di un maestro della scuola di Ise, zona di artigiani specializzati in questo settore.
Anche la decorazione in takamaki-e conferma la richiesta di ornamentazioni più lussuose ed ostentate, in uso in questo periodo. Nella sella come nelle staffe, su di un fondo nashiji (buccia di pera) d’oro color caramello, sono rese in takamaki-e delle carpe fra i flutti (Fig. 12). L’aspetto caratteristico della decorazione a nashiji si ottiene cospargendo su di una base in lacca nera, alcuni strati di particelle metalliche scabre e irregolari (nashiji-fun); ogni strato viene quindi rivestito di lacca trasparente colorata di giallo di gommagutta6 (nashiji-urushi) e lucidato. La superficie dell’opera trattata con questa tecnica decorativa ricorda la buccia della pera giapponese (nashi). Gli effetti differenti che si possono ottenere dipendono dal grado di finezza e densità delle polveri cosparse, oppure dalla presenza di frammenti di foglia metallica o di limatura, nonché dall’aspersione di masse irregolari di particelle.
Le carpe e le onde sono disegnate a basso ed alto rilievo in sabi-urushi e quindi decorate con polvere d’oro cosparsa e applicazioni di foglie dello stesso materiale in varie tonalità. Le lumeggiature della spuma e delle squame dei pesci sono state ottenute mischiando minuscole tessere quadrate o romboidali, ritagliate in lamelle d’oro e applicate l’una accanto all’altra, con qualche piccola particella di lacca nera. Questa tecnica prende il nome di kirikane e serve per accentuare i particolari del disegno.
La pupilla negli occhi delle carpe, disegnata in nero, è stata ricoperta da uno spesso strato di lacca trasparente che, simulando la consistenza acquosa della cornea, conferisce vividezza agli animali (Fig. 13).
Le linee ondulate che accompagnano il movimento dei flutti sono state tracciate in lacca e quindi anche queste spruzzate di polvere d’oro opaca.
Il tema decorativo prescelto per questa sella – le carpe (koi) – è molto usato nell’arte giapponese: quest’animale, particolarmente longevo, che riesce a risalire la corrente e le cascate, interpreta valori quali il coraggio, la resistenza e la perseveranza, incarnando il simbolo maschile per eccellenza.
Di questo insieme, composto sella e staffe (Fig. 14), fa anche parte una barda caratterizzata da grandi quadrati dorati che permette di identificare queste opere con quelle descritte in un altro acquisto proveniente dalla collezione Hodgson: «Horse Armour (large gilt squares) composed of three pieces, and with Chamfren»7.
L’ultima opera che prendiamo in considerazione è un altro cappello da guerra, il n. 8083 (Fig. 15). Questo appartiene alla tipologia Shingen, ovvero con la sommità arrotondata e la parte anteriore della tesa rivolta all’insù. Su di una base di colore scuro, spruzzata di scagliette di madreperla puntiformi, si irradiano quattro sottili fasce nere decorate con motivi vegetali a volute (karakusa), graffite nel fondo e colmate d’oro (kakiwari). Nella parte frontale campeggia in oro il fiore di malvacea (aoi), il mon dei Tokugawa (Fig. 16), la famiglia che regnò in Giappone ininterrottamente dal 1603 al 1867. Questo stemma, conosciuto sin dall’epoca Heian (794-1185), era in origine legato al tempio shintoista Kamo-myōjin, e prima dei Tokugawa in alcune sue varianti era stato usato dalla famiglia Nashida di Tamba ed in seguito dalle famiglie Matsudaira, Honda, Ina e Shimada della provincia di Aichi, nei pressi di Nagoya. La famiglia Tokugawa, originaria dell’est della provincia di Aichi e fedele al tempio di Kamo, prese questo emblema, costringendo il clan Matsudaira a cambiare mon. Già il primo shōgun Tokugawa Ieyasu (1603-1605) aveva proibito ad altri l’uso dello stemma aoi, riservandolo al proprio casato. Questo divieto era osservato rigidamente, tanto che solo in rari casi l’emblema poteva essere mantenuto da una figlia data in sposa ad un membro di un’altra famiglia aristocratica. In questo modo si affermava il predominio del potere feudale nei confronti di quello imperiale, che aveva segnato fino a quel momento le tendenze del gusto e della cultura. I quindici shōgun Tokugawa ed i tre casati Go-sanke (Mito Tokugawa, Kii Tokugawa e Owari Tokugawa) usarono tutti lo stemma aoi con le tre foglie di malvacea iscritte nel cerchio, variando solo ad ogni shōgun il numero delle nervature delle foglie da nove fino a quarantasette. Nonostante questa rigida regolamentazione, è difficile risalire con esattezza ai possessori di un emblema da un particolare numero di nervature, sia perché vennero usati gli stessi stemmi dai vari shōgun, sia perché lo stemma aoi era donato per ricordo o come premio a chi aveva dimostrato fedeltà. Negli ultimi anni del periodo Edo il governo feudale ne concesse l’uso anche ai rami cadetti della famiglia; ed infine con la caduta del potere feudale e la restaurazione Meiji (1867) cadde anche il divieto di usarlo. Le foglie del nostro stemma, realizzato in polvere d’oro secondo la tecnica usuniku-takamaki-e (takamaki-e di basso spessore), hanno diciassette nervature, ottenute alternando oro e aogin (kiru) sulle foglie e sulle linee a tsukegaki. Questa tecnica consiste nell’aggiungere sopra la decorazione a maki-e (pittura cosparsa) linee dipinte a pennello e successivamente spruzzate di polvere metallica.
Attorno alla tesa sono raffigurati due draghi con le teste affrontate, realizzati in lacca rossa, resa cangiante per l’aggiunta di minuscole particelle d’oro, con la tecnica sofisticata del shishiai-togidashi-takamaki-e che permette una decorazione a rilievo su diversi piani. L’aspetto spettacolare del jingasa è accentuato dalla scelta di disegnare i draghi in pose dinamiche. Questo animale fantastico, tatsu, in Giappone è un segno di buon augurio: personificazione degli elementi del cosmo, acqua, terra, aria e fuoco, è simbolo di potenza, trascendenza e supremo coraggio.
La sommità del cappello presenta un’apertura, in giapponese tehen, circondata da una cornice in ottone liscia. Anticamente i giapponesi usavano acconciare i capelli in un codino che, quando indossavano un copricapo, passava nel tehen. Esso era anche il foro per il quale si infondeva nel samurai lo spirito del dio guerriero Hachiman. Quando l’acconciatura a coda passa di moda in favore del mage, il tehen sopravvive unicamente come elemento tradizionale, privo di qualsiasi funzione pratica. Nel nostro jingasa il tehen è addirittura chiuso dalla fodera interna.
Anche questa opera, risalente all’inizio del XIX sec., risponde alle esigenze di rappresentanza proprie del periodo Edo, quando al valore funzionale delle opere si preferisce una decorazione sontuosa ed elegante.
Dalle opere del museo Stibbert che abbiamo esaminato è possibile quindi rilevare come la decorazione nell’equipaggiamento del samurai diventi sempre più preziosa e ridondante nel momento in cui faretre, jingasa, selle o staffe, cessano di avere la funzione prettamente militare per cui erano stati concepite. Del resto sarà proprio la loro ricchezza decorativa ad attirare i collezionisti occidentali, ed in particolare un collezionista colto come Frederick Stibbert, estremamente sensibile non solo all’aspetto simbolico degli apparati militari, quanto alla loro esuberanza ornamentale.
- La lacca si ottiene dal lattice estratto dal tronco della Rhus verniciflua, un albero tipico delle varie regioni dell’Oriente Medio ed Estremo, contenente una sostanza estremamente nociva in grado di produrre gravi irritazioni cutanee, ma con straordinarie proprietà isolanti, sigillanti e adesive. Stesa in uno strato sottile ed uniforme, la lacca infatti crea una pellicola dura, impermeabile, pressoché insolubile e molto durevole. Per le particolari qualità climatiche e del terreno, il lattice prodotto dalla pianta giapponese (urushi) è quello di migliore qualità. In Giappone la raccolta della linfa (urushi eki) inizia nel mese di giugno, quando l’albero giunge a piena maturazione, e termina in novembre; in questo periodo vengono praticate sul medesimo albero da ventidue a venticinque raccolte distanziate nel tempo. La qualità del lattice varia a seconda del mese in cui viene effettuato il raccolto; le più pure sono quelle ottenute tra l’inizio di giugno e la fine di luglio. Naturalmente le lacche migliori sono riservate agli strati superiori di laccatura e alla rifinitura delle opere, mentre le qualità inferiori servono alla preparazione degli strati sottostanti. Questo lento procedimento di raccolta sarà seguito da altre numerose operazioni prima che l’opera in lacca acquisti la sua forma definitiva. Il tempo infatti è parte integrante nella creazione delle lacche, frutto di un paziente procedimento di lavorazione, fatto di gesti reiterati e precisi. La preparazione del supporto in legno è opera di abili maestri artigiani, poiché richiede accurate operazioni di rifinitura. Le asperità e le nodosità vengono asportate e le possibili fessure vengono chiuse con colla, lacca grezza di qualità inferiore e segatura finissima; l’opera viene poi levigata e quindi ricoperta di succo astringente di cachi, che ottura perfettamente i pori del legno. Segue ancora un’ulteriore levigatura ed una mano di lacca grezza.Per rinforzare il supporto si applica su tutta la superficie, o solo sulle parti più fragili o sottoposte all’usura, un rivestimento in tela di canapa o di lino ben tesa ed incollata con un composto di colla e lacca (nori-urushi). Quindi, ancora un rivestimento di lacca grezza (seshime), argilla polverizzata (jinoko) e pasta di riso (komenori), ed una nuova levigatura. Si passa poi alle operazioni di vera e propria laccatura: circa settanta applicazioni sovrapposte fra mesticatura o rivestimento sottostante (shitaji nuri), rivestimento intermedio (naka nuri) e rivestimento finale (uwa nuri). Lo strato inferiore viene applicato con una spatola di legno di cipresso (hera), quelli superiori con pennelli o tamponi di ovatta imbevuti; ogni mano viene lasciata asciugare perfettamente e levigata prima della posa dello strato successivo. Le caratteristiche particolari di ogni fase della laccatura richiedono l’uso di leviganti con diverso potere abrasivo come la polvere di cote inumidita, smerigli e carta vetrata, secchi o inumiditi, o carbone vegetale. Il rivestimento in lacca si consolida solo dopo qualche tempo e per questo viene posto ad asciugare in un apposito mobile rivestito di panni bagnati (furo), che ricrea la temperatura e l’umidità ideali (25-30° gradi centigradi con umidità relativa dell’80-85%) per una perfetta stabilizzazione dell’opera. [↩]
- Dinastia cinese Tang: 618-906. [↩]
- Draghi e peonie. Capolavori della Collezione Giapponese (catalogo della mostra), Firenze 1999, p. 82; Arte Giapponese. Motivi decorativi nel periodo Edo (1603-1868) (catalogo della mostra), Arezzo 1990, p. 194; Robinson H.R., Il Museo Stibbert, Milano 1973. [↩]
- Shimizu C., Lacche giapponesi, Milano 1988, p. 158. [↩]
- Cfr. Archivio Stibbert, Patrimonio Stibbert, Foreign Bills 1887-1897, f. 758. [↩]
- Colorante ricavato dalla gommoresina, presente in alcune piante. [↩]
- Cfr. Archivio Stibbert, Patrimonio Stibbert, Foreign Bills 1887-1897, f. 760. [↩]