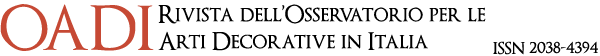di Maria Concetta Di Natale
Vorrei aprire questo terzo numero di OADI – Rivista comunicando un’importante novità: la nascita di Digitalia, una collana di ebook liberamente scaricabili dal sito dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia. La collana è nata con la finalità di proporre una nuova piattaforma in cui possono trovare spazio studi originali dedicati ai diversi ambiti delle Arti Decorative, con una particolare attenzione riservata al mondo dei musei, al collezionismo e all’applicazione delle nuove tecnologie come mezzo innovativo utile allo sviluppo della ricerca storico-artistica e museologica. È on line il primo volume della collana, “Il Museo on line – Nuove prospettive per la museologia” di Nicoletta Bonacasa. La rivista, coerentemente con l’obiettivo principale dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia “Maria Accascina”, ospitando ricerche di studiosi di chiara fama ed esordienti inerenti al settore delle Arti Decorative in Italia e in Europa, si pone come fine principale di promuoverne lo studio e l’approfondimento. Questo numero si apre con un interessante articolo di Paola Venturelli sulla situla di Gotofredo e su quattro copie di età posteriore, due conservate presso il Museo Diocesano “Francesco Gonzaga” di Mantova e due appartenenti a collezioni private statunitensi. Margherita Spinucci presenta un panorama delle stauroteche medievali oggi presenti in Italia, analizzandone le tipologie e la loro evoluzione. Serena Franzon propone una ricerca sui gioielli da capo nelle raffigurazioni quattrocentesche della Vergine Maria, contestualizzandoli nella cultura e nell’arte del tempo. Alessandra Sorce ricostruisce il tesoro perduto della chiesa di Santa Maria di Piedigrotta in Palermo, attraverso lo studio e la pubblicazione di due inventari del 1588 e del 1646. Elvira D’Amico pubblica due nuove parti del parato Papè di Valdina, che lei stessa aveva trattato in occasione della mostra Splendori di Sicilia e della pubblicazione del relativo catalogo nel 2001, custodite presso una collezione privata catanese; l’analisi di questi nuovi elementi le consente di attribuire il parato a Vincenzo La Barbera. L’articolo di Ignacio Miguéliz Valcarlos prende in esame opere di oreficeria siciliana con elementi di corallo custodite in Navarra, ulteriore testimonianza del fitto e continuo scambio di opere ed artisti che interessò le penisole italiana ed iberica in età moderna. María del Mar Nicolás Martínez ricostruisce, attraverso lo studio e la pubblicazione degli inventari delle sculture e delle oreficerie, l’immenso patrimonio artistico di don Fernando Joaquín Fajardo de Requesens y Zúñiga, VI marchese di los Vélez e Vicerè di Napoli dal 1675 al 1683. Benedetta Montevecchi pubblica una parte finora inedita del Tesoro della Cattedrale di Tuscania, quella relativa ai reliquiari donati da monsignor Bartolomeo Bonsignori tra il 1704 e il 1713, che si caratterizzano per il reimpiego di contenitori profani per racchiudere le reliquie di santi e martiri. Lucia Ajello pubblica alcuni albarelli di scuola calatina conservati presso il Museo Nacional de Artes Decorativas di Madrid, realizzati nel XVIII secolo. Giovanni Travagliato, a seguito di un importante ritrovamento presso l’Archivio Storico Diocesano di Palermo, di cui è vicedirettore, pubblica i Capitoli della Congregazione di Sant’Eligio di Palermo, documento del 1844, e un disegno inedito del 1767 di Valerio Astorini, contenuto all’interno del fascicolo con i Capitoli. Il documento è particolarmente importante perché testimonia il persistere del corporativismo tra i maestri artigiani residenti in città anche successivamente all’abolizione definitiva delle maestranze e fornisce un significativo elenco di orafi ed argentieri palermitani attivi in quegli anni. Enrico Colle analizza l’intarsio del piano di un tavolo, opera del 1846 di Francesco Ravaioli, che commemora l’amnistia concessa da Papa Pio IX ai criminali politici. L’opera in questione, oltre a riportare alla memoria uno dei fatti salienti del nostro Risorgimento, fornisce una preziosa testimonianza dell’evoluzione del gusto in area romagnola, dove insieme al persistere di stilemi neoclassici si afferma la tendenza a decorazioni inerenti ai principali avvenimenti politici italiani. Maria Laura Celona ricostruisce, attraverso la testimonianza di Carlo Lo Cicero, da lei stessa raccolta, la vicenda dell’azienda di argenti Formusa, testimonianza dell’intensa attività delle fabbriche italiane nella lavorazione dei metalli preziosi. Chiude questo numero l’articolo di Valentina Filice, che ha per argomento la casa fiorentina di Guglielmo Vita. Lo studio della casa dell’artista e delle sue decorazioni fornisce interessanti spunti, oltre che per una maggiore comprensione dell’uomo e dell’intellettuale, per la ricostruzione del contesto storico e culturale in cui visse ed operò. Concludo ringraziando i colleghi, sia quelli che hanno voluto conferire alto valore scientifico alla rivista con i loro articoli, sia quelli che hanno eseguito i referee sugli articoli stessi, con precisione, rigore e puntualità.