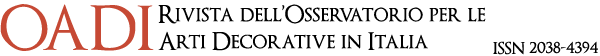priscilla.manfren@unipd.it
«Pittoresche industrie casalinghe»: artigianato e arti applicate coloniali nelle rassegne dell’Italia fascista
DOI: 10.7431/RIV20152019
Questo contributo vorrebbe fornire una panoramica sul tema dell’artigianato e delle arti applicate delle colonie italiane tra anni Venti e anni Trenta del Novecento, proponendo come fil rouge un percorso attraverso alcune delle svariate mostre, spesso inserite in contesti espositivi di più ampia portata, dedicate a tali particolari produzioni. Lo scopo del lavoro è duplice: in primo luogo, esso punta a evidenziare le modalità di strumentalizzazione di queste specifiche produzioni da parte degli enti organizzatori e della propaganda coloniale governativa, desiderando inoltre riflettere sull’atteggiamento che di fronte a esse presentavano, da un lato, gli ‘esperti del settore’, ossia i critici d’arte, dall’altro, l’eterogenea massa dei visitatori di tali rassegne; secondariamente, il saggio vuole porre in luce alcune delle molteplici espressioni della cultura materiale indigena che, in tale arco cronologico, vengono presentate nel contesto italiano come manifestazioni artistiche più evidenti, tangibili e tipiche dei domini nazionali oltremare.
Va premesso che, per quel che concerne l’ambito italiano, le mostre coloniali e le sezioni a tema inserite in esposizioni di svariate tipologie sono state indagate, specie negli ultimi anni, sotto molteplici punti di vista; dopo i primi studi di carattere orientativo, come quelli di Salvatore Bono e Mariastella Margozzi1, sono infatti nati lavori dedicati a specifici aspetti di tali rassegne, quali gli allestimenti, analizzati da Giovanni Arena, i cosiddetti zoo umani, messi in luce da Guido Abbattista, l’arte italiana a soggetto africano esposta in tali mostre, esaminata da Giuliana Tomasella2, sino ad arrivare a numerosi studi, più e meno ampi, che approfondiscono specifiche esposizioni coloniali o rassegne con sezioni a tema, dandone una panoramica o soffermandosi su precisi contenuti3. In merito alle arti applicate d’oltremare va invece segnalato un primo ed interessante contributo redatto, ormai una ventina di anni fa, da Andrea Fabris, che si dedica nello specifico all’arte orafa in Etiopia ed Eritrea durante la dominazione italiana e, fra le altre notizie, fornisce un rapido accenno in merito alla presenza di artigiani indigeni dediti a tale pratica nell’ambito di alcune mostre coloniali4; la prima rassegna italiana in cui risultano presenti prodotti di orafi o argentieri eritrei o etiopici è, stando a Fabris, la Mostra Eritrea nell’Esposizione Nazionale di Palermo del 1891-1892, organizzata per promuovere la conoscenza della più antica colonia africana dell’Italia5. Fin da questo primo caso è evidente come l’aspetto etnografico di simili iniziative si legasse in maniera stretta con l’interesse commerciale ed economico, dato che rassegne del genere non solamente consentivano ai visitatori di avvicinarsi alle popolazioni coloniali attraverso la conoscenza del loro folclore, degli usi e delle tradizioni, ma ugualmente favorivano l’acquisto di prodotti dell’artigianato d’oltremare, non di rado realizzati al momento da indigeni presenti in loco, ospitati in laboratori ed edifici che simulavano i loro quotidiani contesti lavorativi in colonia. La possibilità di utilizzare l’artigianato locale quale suadente mezzo per comunicare l’altrove coloniale al grande pubblico è colta dunque sin dal tardo Ottocento dagli organizzatori delle rassegne, che di fatto con simili produzioni si inseriscono agilmente nel solco tracciato da molte esposizioni internazionali e nazionali che già avevano favorito la diffusione del gusto orientalista; a tal proposito, si pensi per esempio all’Esposizione nazionale svoltasi a Milano nel 1881, in cui il pubblico aveva potuto ammirare gli arredi esposti da Giuseppe Parvis, italiano residente al Cairo e iniziale produttore di mobili artistici, assai apprezzati e richiesti dalle élite locali e dal mercato occidentale, realizzati con un tipo di decoro variamente identificato come arabo, saraceno, moresco, musulmano6. L’importanza della produzione artigianale delle colonie in qualità di vero e proprio strumento di propaganda è però chiara e conclamata soprattutto durante gli anni del fascismo, come dimostrano alcune testimonianze relative alle sezioni indigene presenti nelle due note mostre internazionali d’arte coloniale organizzate, rispettivamente, a Roma nel 1931 e a Napoli nel 1934. In merito alle rassegne indigene organizzate dai vari governi delle colonie italiane (Figg. 1 – 2) e, soprattutto, ai prodotti dell’artigianato esposti nella Mostra dell’Artigianato Tripolino o venduti nelle botteghe del suk ricreato dall’architetto Limongelli al pian terreno di Palazzo delle Esposizioni7, un articolista scrive che quelli che «più o meno, rispondono ai principi d’arte»8 consistono in barracani, tappeti, scarpe ricamate, stuoie, cinture, cuscini, oggetti di oreficeria, lavori in cuoio, e simili (Fig. 3); poco più avanti, lo stesso autore afferma inoltre che «di questi oggetti, di uso più comune, trovasi poi una quantità notevolissima sui banchi del mercato centrale. Qui l’arte non si può dire imperi sempre sovrana, ma forse non è stato male autorizzare l’apertura di botteghe, dove il pubblico possa comprare direttamente dai produttori indigeni (o almeno dall’apparenza di indigeni) le pelli di gazzella nana, le fialette di profumi, i tappeti di uso corrente, gli oggetti di oreficeria, l’hennè, ed altre minutaglie, che non sono certo artistiche, ma che agli scopi di propaganda coloniale servono, presso una certa qualità di pubblico, assai più dei grafici, dei dipinti, dei bronzi»9.
Ugualmente, nel suo saggio sulle arti indigene per il catalogo della mostra d’arte coloniale allestita a Napoli nel Maschio Agioino nel 1934, Mario Scaparro, già autore di testi sull’artigianato tripolino10, sottolinea che l’esposizione e la vendita dei prodotti di arte indigena non significa solamente approfondire la conoscenza dell’animo delle popolazioni locali, ma anche valorizzarne la produzione in un’ottica turistica e, soprattutto, equivale a «fare una intelligente propaganda coloniale che si insinui nell’arte della casa, dell’arredamento e dell’abbigliamento più efficacemente di quanto non faccia un giornale ed una rivista, una conferenza ed un film, cose queste che spariscono mentre l’oggetto d’arte resta»11. Infine, in un articolo del 1936, in cui Angelo Piccioli tira le somme sui risultati delle due grandi rassegne italiane, si legge, a conferma di simili opinioni, che nel 1931 il valore complessivo della mostra era ammontato a circa 80 milioni di lire e che la vendita degli oggetti d’arte applicata, prodotti della lavorazione artigianale tripolina lì rappresentata da tredici espositori, aveva raggiunto la cifra di quasi un milione di lire, mentre quella delle opere d’arte pura era stata di circa centomila lire12; le minuterie indigene dunque, stando a questi dati, avevano fatto breccia tra i visitatori, probabilmente anche per i prezzi contenuti e abbordabili, ben più delle sculture e dei dipinti realizzati dagli artisti italiani.
Da quanto detto sino a ora appare dunque chiaro che, a partire dall’esposizione palermitana del 1891-1892 e con l’espansione italiana in Somalia sul finire dell’Ottocento e in Libia negli anni Dieci del Novecento, la presenza dell’artigianato di fattura coloniale diviene costante e crescente nel panorama delle rassegne italiane. In merito, va però fatta una distinzione sulla provenienza e gli scopi delle tipologie di oggetti esposti: infatti, se da un lato si possono incontrare, come si è visto, prodotti indigeni da bazar orientale, destinati allo smercio per il pubblico dei visitatori (Fig. 4), dall’altro si rintracciano anche singoli oggetti o serie di manufatti di livello più pregiato e raffinato, facenti parte di collezioni private e statali, concesse in prestito per sola esposizione con lo scopo evidente di istruire il pubblico destando, nel contempo, meraviglia e fascinazione. A quest’ultima categoria appartiene, per esempio, la raccolta personale di lavori in oro e argento prestata da Ferdinando Martini, governatore dell’Eritrea, per le rassegne coloniali inserite nell’Esposizione Internazionale di Milano del 1906 e nell’Esposizione Internazionale di Genova del 1914; in queste mostre, come ricorda Chiara Marin, la collezione Martini offriva «un panorama quasi completo degli ornamenti eritrei maschili e femminili sia d’uso quotidiano sia cerimoniale13, rappresentando «per il turista medio il fulcro della Mostra Eritrea»14. Di valore materiale ma anche documentario doveva poi essere la raccolta di gioielli tripolitani ed eritrei in oro e argento, nonché quella di indumenti e tessuti della Libia, inviate dal Museo Coloniale di Roma alla Mostra Coloniale Italiana inserita nella Fiera campionaria di Milano del 1922; evidenti sono gli scopi didascalici e propagandistici di tale mostra che, prima a essere allestita dal Ministero delle Colonie dopo la guerra, è ideata per venire riproposta, nello stesso anno, nelle fiere campionarie di Padova, Napoli e Trieste15. La varietà e la ricchezza della collezione di monili esposti nella mostra itinerante risultano dal completo e dettagliato elenco presente nel catalogo della rassegna milanese, ove i singoli pezzi, purtroppo non suddivisi in base alla provenienza libica o eritrea, sono accompagnati dalla dicitura in lingua indigena. L’elenco è composto da oltre cento elementi (nn. 53-159), fra i quali figurano oggetti come un «cinto verginale (trizain)», dei «pendagli con coralli per le tempie (usciat)», vari spilloni, tra i quali si specificano quelli «per la testa (ghilà-l)», quelli «usati dalle beduine (kalail)» e quelli «con porta profumi (kalail-bu-aghil)», orecchini di varie tipologie fra cui «a mezza luna (alalig hella)», svariati bracciali, come quelli «per polsi (seimeilà)», «per gomiti (dinulì-gg)», «per donna (debleg)», una «crocetta (mascal)», quest’ultima sicuramente di provenienza eritrea, diverse tipologie di collane, fra le quali una «con coralli (aghed-hella)» e due in oro ma di diversa fattura visti i differenti nomi indigeni (mesghinet e lebba zohàb), svariati anelli e pendenti, alcuni dei quali si specifica essere «in filigrana», amuleti in foggia di «manina di Fatima», segno religioso musulmano ed ebraico, e persino una coppia di «gemelli per polsi» recanti il medesimo simbolo16. Come ultimo esempio pare poi interessante ricordare la preziosa ed eterogenea raccolta di cimeli concessa dal Principe di Piemonte in occasione della grande mostra partenopea del 1934. La collezione, i cui pezzi vengono minuziosamente descritti nel catalogo della rassegna, si configura come un insieme di raffinati doni diplomatici, tra cui diversi pugnali e sciabole, per lo più commissionati e offerti da personaggi delle élite indigene, o da specifici gruppi etnici o sociali, delle varie località in cui il principe era passato durante il suo viaggio in Eritrea e Somalia sul finire degli anni Venti17. Per avere un’idea della preziosità e dell’eterogeneità di questa raccolta, consistente in trentasei pezzi, si possono menzionare una «sciabola dall’impugnatura d’avorio» con «fodero in velluto rosso con rivestiture d’oro cesellato e smalti azzurri» e «cintura di velluto rosso con guarnizioni d’oro cesellato e smalti azzurri» donata dagli Eritrei del Seraè18, un billao, tipico pugnale somalo e, in tal caso, specificamente migiurtino, con «impugnatura d’osso con rivestiture di filigrana d’oro», «fodero di cuoio e carta-pecora con rivestiture di filigrana d’oro» e «cintura di cuoio rosso con guarnizioni d’oro cesellato» conservato in un «astuccio in legno intarsiato di forma esagonale», dono del commendatore Ali Jusuf Bahà Iacub di Mogadiscio19, una «croce abissina in oro» del preso di trecentocinquantacinque grammi, conservata in un «astuccio di legno intarsiato con avorio», omaggio degli Eritrei del territorio di Hamasien20, e una «corona d’oro massiccio» del peso di millecentoottanta grammi, riproduzione della Corona Reale Etiopica conservata nel convento del Bizen, racchiusa in «un cofanetto di legno intarsiato con avorio», dono che i cittadini di Asmara avevano offerto al principe insieme agli italiani di Adi Ugri e di Adi Caieh21.
Va poi detto che, con l’evolversi dei traffici e il consolidarsi del dominio italiano nei territori coloniali, in tali rassegne, specie quelle inserite in contesti di carattere più commerciale, compaiono anche oggetti artigianali che utilizzano materiali o stilemi decorativi locali, ma che sono prodotti da italiani residenti in colonia come, fra i tanti casi, sono esempi i cuoi artistici di Carla Dogliani Bordiga di Tripoli22 o i sandali realizzati dalla Ditta di Giovanni Camogli nella cittadina somala di Brava23. Ugualmente, specie per quel che riguarda la produzione di ambito libico, figurano manufatti creati da indigeni inseriti in svariate tipologie di istituti scolastici, come quelli di arti e mestieri e quelli di lavoro e di istruzione per alunne musulmane, presenti sia a Tripoli che a Bengasi, nonché detentivi, come il Carcere Regionale di Bengasi, che vede i lavori dei propri detenuti esposti, al pari di quelli delle alunne della scuola cittadina, nell’ambito della Mostra della Cirenaica allestita nell’esposizione romana del 1931 (Figg. 5 – 6)24; prodotti dell’artigianato libico provengono anche dalle cosiddette scuole-botteghe, sorte verso la metà degli anni Trenta sotto il governatorato di Italo Balbo, gerarca ferrarese particolarmente attento all’arte e alle sue manifestazioni25. Fra i vari istituti, è di particolare rilievo la Scuola di Arti e Mestieri di Tripoli, la cui produzione compare già a Milano nel 192226; la sua vicenda, ricostruita da Francesca Di Pasquale27, rivela come da un certo momento in poi, nell’ottica del progetto fascista di rinascita e rilancio dell’arte e dell’artigianato libici per scopi commerciali e turistici, la presenza di italiani in qualità di supervisori e maestri – noto è il caso del pittore e ceramista sardo Melkiorre Melis28 – fosse divenuta più evidente, come testimoniato dalla fusione di stili presente in numerose creazioni. Se l’attenzione italiana nei riguardi della produzione locale, specie tripolitana, si era rivelata già durante il governatorato di Giuseppe Volpi con l’istituzione sul finire del 1924 dell’Ufficio Governativo delle Arti Applicate Indigene29, da segnalare è anche la costituzione nel marzo del 1936, in pieno periodo balbiano, dell’Istituto Fascista per l’Artigianato della Libia, ente tecnico artistico commerciale con sede a Tripoli, sorto per favorire l’artigianato nazionale e indigeno della regione promuovendo e sviluppando l’attività e il perfezionamento tecnico e artistico, ma anche provvedendo alla selezione, alla raccolta e al commercio, sia in Libia che nel Regno e all’estero, dei diversi oggetti30.
La produzione libica, come si è evidenziato, riveste sin dai primi anni Venti un ruolo preminente nel panorama dell’artigianato e delle arti applicate delle colonie italiane (Figg. 7 – 8), ferma restando in ogni caso l’impossibilità, come si vedrà più volte dichiarata da critici e autori di testi sull’argomento, di poterla elevare al grado di vera e propria arte, relegandola dunque sempre nell’ambito del folclore di una terra rimasta involuta e, proprio per questo, bisognosa della presenza italiana per progredire. Ciò è quanto traspare, ad esempio, dalla breve introduzione del catalogo realizzato dal Governo della Tripolitania per presentare le «piccole industrie tripoline» convenute a Firenze nel 1923 alla Prima Esposizione Nazionale delle piccole industrie e dell’artigianato31; qui si legge infatti che «la Tripolitania non è terra di industrie. Mille anni di supremazia islamica hanno tolto ad essa il ritmo veloce di altre terre; le attività umane, rivolte specialmente alla pastorizia ed alla agricoltura, si sono fermate negli altri campi all’artigianato ed alle piccole, pittoresche industrie casalinghe. I prodotti del lavoro tripolino rivestono dunque, più che altro, un carattere di curiosità […]. Tutto è patriarcale in questo artigianato libico, e tutto è primitivo, dalle stuoie alle corde di sparto, agli oggetti agricoli o al cuoio conciato e lavorato. L’osservatore troverà materia di molte riflessioni guardando i prodotti indigeni della attività tripolitana e constaterà come un paese fermatosi a questo stadio infantile di lavoro e di produzione possa aspettare un avvenire migliore soltanto da un paese che lo popoli di altra gente e vi innesti altre più fresche energie. Questo l’Italia sta facendo attraverso la colonizzazione che incomincia, e che renderà la Tripolitania meno pittoresca ma più florida di prodotti e più moderna di sistemi e di lavoro»32.
Due anni più tardi, nel 1925, non dissimile è il messaggio che traspare dai commenti sulle otto sale della Sezione delle Colonie Italiane allestita a Monza (Fig. 9)33, nell’ambito della Seconda Mostra Internazionale delle Arti Decorative. L’esposizione, diretta da Guido Marangoni, apre i battenti più o meno in contemporanea alla concorrenziale Exposition Internationale des Art Décoratifs et Industriels Modernes organizzata a Parigi. Probabilmente per tale motivo, presumendo che l’esposizione francese avrebbe assorbito le già esigue attività italiane del settore, la rassegna monzese sviluppa notevolmente il filone della cosiddetta arte rustica o paesana, caratterizzata da aspetti curiosi, pittoreschi e folcloristici. Le note negative per tale scelta si palesano negli articoli di autori come Margherita Sarfatti, Giovanni Felice Rossi e Roberto Papini34, i quali sottolineano la necessità di una selezione fatta con maggior rigore, al fine di evitare che la rassegna finisca per trasformarsi in una «fiera campionaria delle industrie locali – mediocre, senza importanza e di scarso giovamento per l’arte»35. L’artigianato rurale è apprezzato nei suoi limiti, a patto che esso si inserisca nell’alveo della tradizione, tramandando metodi di lavorazione e stilemi figurativi, conciliando la bellezza con l’utilità. A tal proposito, in un commento che, tutto sommato, pare lodare l’immutabilità delle forme e degli stilemi della produzione coloniale, Sarfatti scrive: «il proprio e il caratteristico delle piccole industrie paesane è proprio la fedeltà al tipo vetusto, trasmesso per tradizione. Questo, anzi, le rende particolarmente interessanti e commoventi, come segni della perennità e augusta semplicità della stirpe, ricorrente a uguali forme, nell’uguale espressione di immutati bisogni. Di questa immobilità non morta – la stessa linfa ripullula allo stesso millenne tronco in simili foglie – la mostra delle colonie, Tripolitania e Cirenaica, è il prototipo. Più la vita è elementare e limitata, meno si evolve e muta con maggior lentezza. Le produzioni dell’artigianato patriarcale, di figlio in padre, dalla nipote alla bisavola, ci conducono a ritroso pei secoli sino alla Bibbia e più addietro; mutare, sarebbe quasi desecrare quelle forme definitive»36.
Più duro nel giudizio è Papini che, nel contemporaneo dibattito sui modi e sui modelli utili a ravvivare e migliorare la coeva produzione di arti applicate in Italia, si schiera nettamente contro quanti additassero come risolutiva l’ispirazione tratta dalle manifestazioni della cosiddetta arte rustica, a suo parere sempre uguali a se stesse e noiosamente ripetitive in ogni parte del mondo, tanto da fargli comparare e ritenere affini la produzione russa e quelle dei domini italiani oltremare; Papini osserva infatti che «ormai dopo aver visto tanti saggi di ciò che i pastori e i contadini sanno fare, anche i più ottimisti si sono accorti che le arti rustiche d’ogni paese si somigliano fra loro e si ripetono in maniera stucchevole […]. Chi non ne fosse persuaso confronti il Messico con la Lituania, la Puglia con la Polonia, la Russia con le Colonie nostre d’Africa, la Romania con la Sicilia nei saggi che da ogni paese sono affluiti a Monza e vedrà quanto tutte le arti rustiche, col loro fondamento di geometria violentemente colorata e col loro primitivismo infantile, siano apparentate fra loro»37. Lo stesso Papini, nel recensire alcuni anni dopo la mostra d’arte coloniale di Roma, fa nuovamente presente la propria negativa considerazione in merito alle ‘arti rustiche’, e di conseguenza alle produzioni coloniali che ad esse apparenta, avviando il proprio articolo con una secca e dequalificante affermazione in merito a queste ultime; egli scrive infatti: «Arte coloniale? Se si tratta di quella dei paesi da colonizzare dai ghiacci dell’Artide o dell’Antartide al bollore dei Tropici, su per giù la conosciamo e l’abbiamo da tempo, a torto o a ragione, catalogata nel mezzo delle arti rustiche o primitive o contadinesche o selvagge, cioè, nella gerarchia delle arti, ai gradi inferiori»38. Il critico toscano non si esprime negativamente solo a riguardo delle produzioni indigene, ma sottolinea la propria ostilità anche circa i sistemi di promozione delle arti autoctone adottati in colonia dalle varie potenze europee, Italia compresa; egli osserva che proteggere la produzione locale tale e quale essa è o avviare gli indigeni a far rivivere forme e generi andati in disuso sono due azioni che, in realtà, non portano alla popolazione coloniale alcun progresso e incivilimento in campo culturale e artistico. Papini, che pur non si trattiene dallo scrivere giudizi negativi e di stampo razzista sugli indigeni, sottolinea che «incivilire dovrebbe essere sinonimo di elevare. Prendere cioè i meglio dotati fra gli indigeni ed abituarli per gradi e per selezioni successive ad emanciparsi dalla pedissequa ripetizione dei motivi che risponde alla loro indole barbarica e infingarda. Le scuole dovrebbero essere sorvegliate da artisti con l’occhio attento non soltanto alle particolari tendenze della razza ma alle disposizioni speciali dei singoli individui in modo da svilupparle nelle direzioni che essi spontaneamente prendono, non da costringerle alla noiosa ripetizione o alla copia»39.
Per concludere, pare interessante riportare uno stralcio di testo tratto dal citato saggio di Mario Scaparro sulle arti indigene in mostra a Napoli nel 1934. Lo scrittore qui, per chiare necessità di propaganda, sembra riuscire a destreggiarsi e a non prendere, almeno all’apparenza, una posizione così netta e drastica, per quanto concerne il giudizio estetico sulla produzione coloniale, come invece aveva fatto Papini. Scaparro mantiene infatti un atteggiamento ambiguo e, pur presentando le creazioni dell’Oltremare italiano come incomparabili dal punto di vista artistico con quelle di qualsiasi provinciale produzione italiana, le addita, nel contempo, come modelli esemplari di un’arte non fine a se stessa – dunque di arte applicata – «funzionale», «razionale» e addirittura «futurista». Nelle pagine iniziali del suo saggio, egli scrive infatti: «Senza pretendere di assegnare alle arti indigene delle nostre Colonie il posto che nella storia dell’arte occupano le arti di una qualsiasi provincia italiana, pur tuttavia quelle primitive delle nostre Colonie orientali che ricordano una vita patriarcale di quattromila anni fa, e le arti libiche che risentono dell’influenza di tutte le dominazioni che si sono succedute su quelle terre, formano un complesso di eccezione sul quale la Mostra d’Arte Coloniale di Napoli richiamerà l’attenzione dell’artista, dello studioso, del turista. […]. Le arti indigene libiche si differenziano da quelle somale ed eritree, oltre che per la profonda differenza di storia e di civiltà di quei popoli, per le condizioni geografiche, per le materie prime esistenti in luogo, per la tecnica diversa. Alcuni caratteri sono però comuni a tutte e quattro le nostre colonie: le colorazioni accese con predominio del rosso, del turchino, dell’arancione, tipici dei popoli del sud; la forma netta senza sfumature; l’arte non fine a se stessa, ma considerata quale ornamentazione di oggetti utili, applicata seguendo i bisogni utilitari e non violando la materia o le esigenze che l’oggetto è destinato a soddisfare. Arte funzionale, razionale o futurista – dunque – che da secoli vive in terra d’Africa»40.
- Si veda in generale il volume L’Africa in vetrina. Storie di musei e di esposizioni coloniali in Italia, a cura di N. Labanca, Paese (Treviso) 1999, e in particolare S. Bono, Esposizioni coloniali italiane. Ipotesi e contributo per un censimento, ivi, pp. 17-36; M. Margozzi, Per una storia dell’Arte coloniale attraverso le esposizioni. Formazione e sviluppo delle collezioni di pittura, scultura e grafica del Museo Africano, in Dipinti, Sculture e Grafica delle Collezioni del Museo Africano, Roma 2005, pp. 1-28, e in particolare le pp. 2-16. [↩]
- Si segnalano qui i principali contributi degli autori menzionati: G. Arena, Visioni d’oltremare. Allestimenti e politica dell’immagine nelle esposizioni coloniali del XX secolo, Napoli 2011; G. Abbattista, Umanità in mostra. Esposizioni etniche e invenzioni esotiche in Italia (1880-1940), Trieste 2013, reperibile online <https://www.openstarts.units.it/handle/10077/9484>; G. Tomasella, Esporre l’Italia coloniale. Interpretazioni dell’alterità, regesto delle esposizioni di P. Manfren- C. Marin, Padova 2017. [↩]
- Assai numerosi sono divenuti, negli ultimi anni, i contributi su queste tematiche. Se ne segnalano qui alcuni, a titolo esemplificativo, per dare un’idea della varietà dei risvolti delle ricerche: G. Pettena, La fiera campionaria di Tripoli (1927-1939), tesi di dottorato, XIX ciclo, dottorato in Storia dell’architettura e dell’urbanistica, tutor E. Godoli, Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Storia dell’architettura e della città, 2008; A. Roscini Vitali, Fra orientalismo e modernità: la Mostra d’arte coloniale a Roma, in In corso d’opera. Ricerche dei dottorandi in Storia dell’Arte della Sapienza, a cura di M. Nicolaci-M. Piccioni-L. Riccardi, Roma 2015, pp. 301-307; G. Arena, The Last Exhibition of the Italian Colonial Empire: Naples 1938-40, in Cultures of International Exhibitions 1840-1940. Great Exhibitions in the Margins, edited by M. Filipová, London 2016, pp. 313-332; D. Jarrassé, Usage fasciste de l’art colonial et dénis d’histoire de l’art. Les Mostre d’arte coloniale (Rome 1931 et Naples 1934), in “Studiolo”, n. 13, 2016, pp. 236-263; R. Ferlito, Re-inventare l’italianità: la Triennale delle Terre italiane d’Oltremare di Napoli, in “Roots&Routes”, a. VI, n. 23, settembre-dicembre 2016, online <https://www.roots-routes.org/re-inventare-litalianita-la-triennale-delle-terre-italiane-doltremare-napoli-alessandra-ferlito/>, consultato il 2 novembre 2019; C. Belmonte, Staging colonialism in the ‘other’ Italy. Art and ethnography at Palermo’s National Exhibition (1891/92), in “Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz“, n. 1, 2017, pp. 86-108; P. Manfren, Il caso delle mostre e degli allestimenti coloniali alla Fiera di Padova, in “Ricerche di S/Confine”, dossier 4 (Esposizioni, atti del convegno internazionale, Parma 27-28 gennaio 2017, a cura di F. Castellani et alii), 2018, pp. 379-392, online <https://www.ricerchedisconfine.info/dossier-4/dossier4-2018.pdf>, consultato il 12 novembre 2019; C. Belmonte, Colonial Visual Culture and the Practice of Human Display in 19th Century Italy, in “Quadrante”, n. 21, 2019, pp. 159-172, online <http://repository.tufs.ac.jp/bitstream/10108/93326/1/ifa021016.pdf>, consultato il 2 novembre 2019. [↩]
- A. Fabris, L’esperienza dell’oreficeria etiopica ed eritrea in ambito coloniale, in “Africa”, a. LIV, n. 2, 1999, pp. 244-263. Alle pp. 253-259 lo studioso tratta velocemente il tema, accennando alle rassegne o alle sezioni coloniali inserite nei seguenti contesti espositivi: l’Esposizione Nazionale di Palermo (1891-1892); l’Esposizione Internazionale di Torino (1911); l’Esposizione Internazionale di Genova (1914); l’Esposizione di Torino (1928); la Prima Mostra Internazionale d’Arte Coloniale di Roma (1931); la Seconda Mostra Internazionale d’Arte Coloniale di Napoli (1934-1935); la I Mostra dell’Impero Coloniale Italiano di Napoli (1936); la Mostra dell’Etiopia Italiana indetta dal Comitato Fiorentino della “Dante” (1936); la Fiera del Levante di Bari (1936); la Prima Mostra Triennale delle Terre Italiane d’Oltremare di Napoli (1940). [↩]
- In merito a tale rassegna, oltre a quanto compare in C. Belmonte, Staging colonialism…, in “Mitteilungen des Kunsthistorischen…, 2017, pp. 98-102, si veda C. Marin, IV Esposizione Nazionale Italiana, Palermo, 15 novembre 1891-5 giugno 1892, in G. Tomasella, Esporre l’Italia coloniale…, 2017, pp. 118-120. [↩]
- Cfr. O. Selvafolta, “Il Signor Parvis del Cairo all’Esposizione del 1881: la diffusione del gusto e dell’ornato orientalista, in Mondi a Milano. Culture ed esposizioni 1874-1940, catalogo della mostra (Milano, MUDEC-Museo delle Culture, 27 marzo-19 luglio 2015), Milano 2015, pp. 68-77. [↩]
- Un’interessante testimonianza è il Giornale Luce A0887 del 11/1931, relativamente alla parte “A Roma la Prima Mostra Internazionale d’arte coloniale”, pubblicata il 15 giugno 2012, online <https://www.youtube.com/watch?v=L44SUbe28qM&t=1s>, consultato il 12 novembre 2019. [↩]
- S.G., La Mostra Internazionale d’Arte Coloniale, in “Rivista delle Colonie Italiane”, a. V, n. 11, novembre 1931, pp. 831-834: 833. [↩]
- S.G., La Mostra Internazionale…, in “Rivista delle Colonie…”, 1931, pp. 833-834. [↩]
- Si vedano M. Scaparro, L’artigianato tripolino, Tripoli 1932; Idem, L’artigianato tripolino, in “Rivista delle Colonie Italiane”, a. VII, n. 1, gennaio 1933, pp. 58-65. [↩]
- M. Scaparro, Arti indigene delle colonie italiane, in II Mostra Internazionale d’Arte Coloniale. Catalogo, Roma 1934, pp. 249-262: 250. [↩]
- Cfr. A. Piccioli, L’Arte coloniale, in “Rivista delle Colonie (L’Oltremare)”, a. X, n. 7, luglio 1936, pp. 727-747: 729. [↩]
- C. Marin, Esposizione Internazionale di Milano o “Esposizione del Sempione”, Milano, 28 aprile-11 novembre 1906, in G. Tomasella, Esporre l’Italia coloniale…, 2017, pp. 126-130: 129. [↩]
- C. Marin, Esposizione Internazionale di Marina e di Igiene Marinara. Mostra Coloniale Italiana, Genova, 12 maggio-15 dicembre 1914, in G. Tomasella, Esporre l’Italia coloniale…, 2017, pp. 135-143: 141. [↩]
- Per queste e altre notizie in merito si veda P. Manfren, Fiera Campionaria di Milano, Milano, 12-27 aprile 1922, in G. Tomasella, Esporre l’Italia coloniale…, 2017, pp. 144-147. [↩]
- Cfr. Padiglione A. Raccolta di prodotti e di oggetti provenienti dalle quattro colonie e dal museo coloniale, in Guida della Mostra Coloniale Italiana nella III Fiera Campionaria di Milano. 12-27 aprile 1922, Roma 1922, s.p., nn. 53-159 e nn. 185-250. [↩]
- La collezione deve essere la medesima che il principe aveva già concesso per la Mostra delle Colonie allestita nell’Esposizione di Torino del 1928; dal catalogo di quest’ultima, infatti, si apprende che nel Salone centrale del Padiglione d’onore della rassegna coloniale, allestita nell’area del Pilonetto, figurava la «raccolta di doni offerti a S.A.R. il Principe Ereditario dalle popolazioni dell’Eritrea e della Somalia in occasione del Suo recente viaggio in quelle Colonie» (cfr. Torino 1928. Catalogo Ufficiale: Esposizioni Permanenti, maggio-novembre-Parco del Valentino, Torino 1928, p. 359). [↩]
- Cimeli (Proprietà di S.A.R. il Principe di Piemonte), in II Mostra Internazionale d’Arte Coloniale…, 19342, pp. 53-60: 53, n. 3. [↩]
- Cimeli (Proprietà di …, in II Mostra Internazionale d’Arte Coloniale…, 19342, p. 55, n. 9. [↩]
- Cimeli (Proprietà di…, in II Mostra Internazionale d’Arte Coloniale…, 19342, p. 59, n. 30. [↩]
- Cimeli (Proprietà …, in II Mostra Internazionale d’Arte Coloniale…, 19342, p. 60, n. 32. [↩]
- Gli oggetti prodotti da Carla Dogliani Bordiga compaiono ad esempio a Milano nel 1922, a Tripoli nel 1927, a Torino nel 1928 (cfr. Padiglione B. Tripolitania. Elenco degli Espositori, in Guida della Mostra Coloniale Italiana…, 1922, s.p., n. 4, e nelle pagine successive si specifica che suoi sono i lavori nn. 224-229, ossia: «cornice grande in cuoio sbalzato con pergamena miniata», «cuscino delle rose in vitello finissimo»,«cuscino grande (presa d’un forte)», «cuscino arabo», «cuscino stile mussulmano», «bibliotechina da scrittoio in legno»; Catalogo della Mostra della Tripolitania alla Ia Fiera Campionaria di Tripoli, Tripoli 1927, p. 42; Torino 1928. Catalogo Ufficiale…, 1928, p. 362). [↩]
- La Ditta Camogli, specializzata nella lavorazione di pelli di animali della fauna somala, compare con i propri prodotti, fra le altre, a Milano nel 1922, a Torino nel 1928, a Roma nel 1931 (cfr. Padiglione B. Somalia Italiana. Elenco degli Espositori, in Guida della Mostra Coloniale Italiana…, 1922, s.p., e nelle pagine successive si specifica che suoi sono i lavori nn. 59-80, tra i quali figurano svariate tipologie di sandali che possono essere di «tipo comune per bagno o camera», «tipo comune da bambini», «tipo ricamato di lusso», «tipo arabo per uomo», ma anche, stando alle diciture, modellati sulle fogge in uso in alcune precise città somale, come quelli «tipo Brava», «tipo Cheren «tipo Massaua da donna»; Torino 1928. Catalogo Ufficiale…, 1928, p. 264; Sala XIII. Mostra della Somalia Italiana, in I Mostra Internazionale d’Arte Coloniale. Catalogo, Roma 19312, pp. 244-255: 255). [↩]
- Cfr. La Mostra della Cirenaica, in “L’Italia Coloniale”, a. VIII, n. 12, dicembre 1931, p. 201; Sala XII. Mostra della Cirenaica, in I Mostra Internazionale d’Arte Coloniale…, 19312, p. 233. [↩]
- Cfr. G. Quadrotta, Sviluppo e realizzazioni dell’artigianato in Libia, in “Rassegna economica dell’Africa Italiana”, a. 25, n. 7, luglio 1937, pp. 952-967: 953-956. L’impegno di Balbo è ricordato anche in: F. Corò, L’artigianato libico nell’interno della Tripolitania, Tripoli 1938, pp. 20, 26; G.E. Pistolese, Ascesa dell’artigianato libico, in “Africa Italiana”, a. II, nn. 3-4, marzo-aprile 1939, pp. 22-24. Sul mecenatismo balbiano in Libia nei confronti artisti italiani si veda invece L. Scardino, Ferrara in Libia: appunti sulla corte di Italo Balbo, in Permanenze e metamorfosi dell’immaginario coloniale in Italia, a cura di E. Castelli-D. Lorenzi, Napoli 2000, pp. 241-252. [↩]
- Qui spiccano per la particolarità e l’elevato prezzo, fra borsette arabe, pantofole in velluto, portafogli e barracani, un «barracano di seta ed argento» in vendita a 1255 lire, un «tavolinetto in legno intagliato, stile arabo» a 650 lire, un «trespolino di legno in stile arabo (portafiori)» a 550 lire (cfr. Padiglione B. Tripolitania. R. Scuola di Arti e Mestieri di Tripoli, in Guida della Mostra Coloniale Italiana…, 1922, s.p.). [↩]
- Si vedano: F. Di Pasquale, La Scuola per l’Impero. Politiche educative per gli arabi di Libia in epoca fascista (1922-1940), tesi di dottorato, anno inizio corso: 2003, dottorato in Storia, istituzioni e relazioni internazionali dei Paesi extraeuropei, Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Scienze della Politica, relatore S. Bono, pp. 117-132, online <https://core.ac.uk/download/pdf/14693793.pdf>, consultato il 10 novembre 2019; Eadem, La Scuola di arti e mestieri di Tripoli in epoca coloniale (1911-1938), in “Africa”, a. LXII, n. 3, 2007, pp. 399-428. [↩]
- Melis, chiamato in Libia da Balbo nel 1934 per condurre la Scuola Artigiana di Ceramica Libica, assume poi la direzione artistica della Scuola di Arti e Mestieri, che includeva quella di ceramica; in merito all’attività coloniale di Melis si vedano: A. Cuccu, Melkiorre Melis, Nuoro 2004, pp. 86-98; Idem, Melchiorre Melis e la Scuola Musulmana di Arti e Mestieri a Tripoli, in Mondi a Milano…, 2015, pp. 212-213; G. Arena, L’immagine delle colonie. La vicenda creativa di Melkiorre Melis alla Prima Mostra Triennale delle Terre Italiane d’Oltremare, in Artisti sardi e orientalismo: altri esotismi, volume edito in occasione della mostra (Sassari, Museo dell’arte del Novecento e del Contemporaneo-Convento del Carmelo, 2 marzo-15 giugno 2017), a cura di M.P. Dettori, Cinisello Balsamo 2017, pp. 53-71. [↩]
- Una prima panoramica sulle produzioni tripolitane (in particolare sui tappeti di Misurata, i megrum, le stuoie e la lavorazione di argento, oro, avorio, legno, ottone, rame) e sull’attività dell’Ufficio è fornita da Francesco M. Rossi, direttore dell’Ufficio stesso (cfr. F.M. Rossi, Le piccole industrie indigene, in La rinascita della Tripolitania: memorie e studi sui quattro anni di governo del conte Giuseppe Volpi di Misurata, Milano 1926, pp. 513-519. Tuttavia, a detta di Francesco Corò (cfr. F. Corò, L’artigianato libico…, 1938, pp. 5-6), il lavoro più originale e pionieristico sull’artigianato tripolitano, a cui tutti per anni attingono, è quello realizzato dal francese Prosper Ricard, direttore del Servizio di Arti Indigene del Marocco, che lo pubblica in due tranche nel 1926 (P. Ricard, Les arts tripolitains, in “Rivista della Tripolitania”, a. II, n. IV, gennaio-febbraio 1926, pp. 203-235; Idem, Les arts tripolitains, in “Rivista della Tripolitania”, a. II, n. V, marzo-aprile 1926, pp. 274-293). [↩]
- Cfr. G. Quadrotta, Sviluppo e realizzazioni…, in “Rassegna economica…”, 1937, pp. 956-960. Nel testo compare anche un elenco delle maggiori manifestazioni fieristiche, quindici in tutto, ove la produzione libica è stata esposta a partire del 1934, ossia: Mostra Internazionale d’Arte Coloniale di Napoli; IX Fiera Internazionale di Tripoli; V Fiera Nazionale dell’Artigianato di Firenze; Esposizione Universale di Bruxelles; Settimana Coloniale di Fiume; Mostra Coloniale del Giugno Genovese; VI Fiera del Levante di Bari; X Fiera di Tripoli; VI Mostra-Mercato dell’Artigianato di Firenze; Mostra del Libro Coloniale di Roma; VIII Fiera del Levante di Bari; VI Triennale di Milano; XI Fiera di Tripoli; XVIII Fiera di Milano; VII Mostra Mercato dell’Artigianato di Firenze. A queste vanno aggiunte rassegne private, organizzate presso importanti empori fra cui La Rinascente di Milano (ne rimane traccia in una copia del bel manifesto realizzato per l’occasione da Marcello Dudovich, conservata presso la Fondazione Massimo e Sonia Cirulli, online <http://fondazionecirulli.org/artwork/mostra-coloniale-dellartigianato-libico-alla-rinascente/>, consultato il 10 novembre 2019). Quadrotta segnala inoltre la presenza di mostre permanenti dei prodotti artigiani libici presso la sede di Roma dell’Ente Turistico ed Alberghiero dello Libia e presso le Sale Campionarie di Firenze dell’Ente Nazionale per l’Artigianato e le Piccole Industrie. [↩]
- Governo della Tripolitania, Le piccole industrie tripoline alla Esposizione Nazionale di Firenze. Primavera MCMXXIII, Tripoli 1923. Il catalogo elenca numerose categorie e sottocategorie di prodotti, anche qui specificando i singoli oggetti e accompagnando ogni voce con la dicitura indigena: a) tessuti (di lana, di cotone, di seta); b) lavori in pelle, tintoria ed altri; c) oreficeria (in argento, in oro); d) lavori in avorio – penne di struzzo; e) strumenti musicali; f) attrezzi agricoli; g) lavori in giunco, sparto e foglie di palma; h) lavorazione dei metalli; i) lavori da vasaio; l) distillazione. A queste categorie si aggiungono quelle non identificate da lettere progressive di «una sella araba», «tabacchi», «sale», «la pesca delle spugne», «pesca del tonno», «Scuola d’arti e mestieri», «industrie femminili italiane», «scuola di istruzione e lavoro per le alunne mussulmane», «Regia soprintendenza scolastica della Tripolitania». [↩]
- O.P., [testo introduttivo] in Governo della Tripolitania, Le piccole industrie tripoline…, 1923, p. 3. [↩]
- In merito alla sezione coloniale: P. Manfren, Seconda Mostra Internazionale delle Arti Decorative, Monza, maggio-ottobre 1925, in G. Tomasella, Esporre l’Italia coloniale…, 2017, pp. 147-148. [↩]
- Cfr. M.G. Sarfatti, Le Arti Decorative a Monza, in “La Rivista Illustrata del Popolo d’Italia”, a. III, n. 7, luglio 1925, pp. 41-45; G.F. Rossi, Cronache varie. La II Biennale delle Arti Decorative a Monza, in “Emporium”, vol. LXI, n. 364, aprile 1925, pp. 268-271; R. Papini, Le Arti a Monza nel 1925. I.-Dagli architetti ai pastori, in “Emporium”, vol. LXII, n. 369, settembre 1925, pp. 138-160. [↩]
- M. G. Sarfatti, Le Arti Decorative a Monza…, in “La Rivista Illustrata…”, 1925, p. 41. [↩]
- M. G. Sarfatti, Le Arti Decorative a Monza…, in “La Rivista Illustrata…”, 1925, p. 42. [↩]
- R. Papini, Le Arti a Monza nel 1925…, in “Emporium”, 1925, p. 159. [↩]
- R. Papini, Prima Mostra Internazionale d’Arte Coloniale: Arte e Colonie, in “Emporium”, vol. LXXIV, n. 443, novembre 1931, pp. 267-284: 267. [↩]
- R. Papini, Prima Mostra Internazionale …, in “Emporium”, 1931, p. 272. [↩]
- M. Scaparro, Arti indigene…, in II Mostra Internazionale…, 19342, pp. 249-251. [↩]