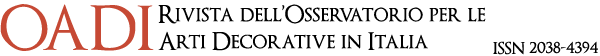rosaromano7@gmail.com
La cultura orafa calabrese fra arte e memoria
DOI: 10.7431/RIV20132019
Tra Settecento e Ottocento, grazie a una nuova ondata di benessere in tutta Europa, il gioiello divenne per i nuovi ceti borghesi, un elemento qualificante con risvolti anche fra le classi più umili che videro nell’oro un simbolo di riscatto sociale1. Fu proprio in questo momento che si aprirono le prime fabbriche orafe in Germania e in Italia ma anche le aziende artigianali minori si dotarono di nuove attrezzature per una produzione più vasta. Per accelerare il lavoro si cominciò a stampare con piccole presse a pedale, lamine d’oro che assemblate e rifinite davano vita a monili più leggeri e facili da indossare.
Anche in Calabria nacquero diversi laboratori, in particolare in area cosentina2. Del resto, l’esistenza di miniere di argento a Longobucco, nella Sila greca, aveva già favorito la lavorazione di metalli preziosi. Accanto all’attività estrattiva, era nata, infatti, una manifattura che, già tra il 1191 e il 1202, aveva realizzato dei calici per l’Abbazia di Gioacchino da Fiore3. La provenienza del piede del reliquiario di San Demetrio Corone da una bottega locale, forse cosentina, inoltre, avvalora anche la tesi di una produzione orafa antica4. A Cosenza si riscontrano, infatti, diverse testimonianze di questa manifattura già in epoca medioevale mentre altre città come Acri, Catanzaro e San Giovanni in Fiore cominciarono a diventare produttive presumibilmente a fine Settecento. Attestano questa tradizione alcuni documenti di varia provenienza in cui compaiono, fra l’altro, i nomi di molti orafi: come Simillo (de) Guglielmo da Cosenza, orefice alla corte del re angioino nel 12705, Giustino Giudone nel 1574 a Nicotera6, Placido Bonanni (1632-34), maestro incisore di Cosenza7, successivamente Tommaso Serra (Cs) e Vincenzo Silipo (Cz)8, e molti altri maestri di origine calabrese attivi in area meridionale. Un’ulteriore testimonianza dell’estensione sul territorio di quest’attività e del suo flusso sta nel fatto che Cosenza, insieme a Catanzaro e a poche altre città scelte del regno, ebbe la facoltà di avere dei saggiatori di garanzia subito dopo l’istituzione nel 1808 nella Capitale di un “burò” per valutare gli oggetti d’oro9.
In una lettera del 6 dicembre 1814, infatti, gli argentieri e orefici cosentini scrissero al Ministro delle Finanze, lamentando il disagio di doversi spostare a Pizzo per marcare i lavori10. A metà Ottocento a Cosenza si registravano otto gioiellerie e officine per la lavorazione dell’oro e dell’argento con sessantaquattro operai11, e si conosce l’esistenza di una via degli Orefici, oggi corso Telesio, e una piazza degli Argentieri già dal 1571, come risulta da un documento dell’11 maggio conservato nell’Archivio di Stato locale12. C’erano, dunque, quartieri specializzati dove si aggregavano i laboratori e dove si svolgeva il commercio, anche se continuava l’abitudine di vendere gioielli durante le fiere di paese dove l’orafo si recava con la vetrinetta sulle spalle. Sempre a metà Ottocento, i documenti riguardanti il Monte di pietà evidenziano l’esistenza di numerose botteghe operanti su questo territorio (Luigi Gallo di Cosenza, Raffaele Scaglione, Pasquale Barone, Don. Giuseppe Martino e Don Giovanni Parise, Raffaele Sannuti e Gaetano Noce). E anche quando gli stessi orafi dichiararono in un certificato che la professione di gioiellieri era esercitata a Cosenza dai soli Raffaele Sannuti e Raffaele Scaglione13 intendevano, presumibilmente, distinguere il Fabbricante di lavori di gioie che aspirava a lavorare come ordinario al Monte e le normali botteghe. La situazione si chiarisce, infatti, nel 1853 quando la commissione del Monte, dopo un periodo di stasi causato dalla malattia dell’orefice interno Raffaele Scaglione, indisse una graduatoria di possibili aiuti dell’orafo: Luigi Gallo per primo, Giuseppe Martino e Giovanni Parise, con forti divergenze su chi dovesse sostituire lo Scaglione come ordinario.
Tutta questa documentazione ci induce a credere che le manifatture di oreficeria non solo fossero presenti ma radicate sul territorio e considerando che i nobili erano portati, per gli oggetti di maggior valore, a rivolgersi alla Capitale, queste lavoravano principalmente per il popolo cui questi oggetti preziosi conferivano dignità sociale, protezione apotropaica e terapeutica grazie al valore di inalterabilità dell’oro che andava al di là di ogni moda.
Su tutto il territorio calabrese, con differenze legate alle tradizioni locali, fu il rito della promessa di matrimonio il momento in cui gli oggetti preziosi divennero il segno principale dello stato economico. Era quella, infatti, l’occasione in cui, davanti ad un orafo che diventava un testimone, la sposa ma, a volte, anche tutte le componenti femminili della sua famiglia, perfino le più piccole, dopo un momento di ritrosia iniziale dettato dalla buona educazione, sceglievano un oggetto d’oro (Fig. 1). In alcuni casi questi gioielli erano consegnati alla futura nuora direttamente dalla suocera, che provvedeva ad adornarla come in un passaggio ancestrale e matriarcale (Fig. 2).
Attraverso la simbologia dei monili e dell’abito tradizionale della cosiddetta “pacchiana” si mandavano precisi segnali del livello sociale e del potere dei gruppi familiari ma anche dello stato della donna. Attraverso i colori del verde e del rosso si distingueva, infatti, la nubile dalla maritata e i toni scuri dell’ebano, dell’onice e della tartaruga (materiale raro in quest’area geografica) manifestavano il suo lutto. I viaggiatori stranieri descrivevano le donne del popolo cosentino, e calabrese più in generale, con indosso gioielli cromaticamente di grande effetto, anche se di oro a bassa caratura con pietre a pasta vitrea di poco valore, ma con tipologie tanto creative da rapportarsi in modo dialettico con quelli delle dame più abbienti. Emma Calderini14 nel raccontare il costume della “pacchiana” di Luzzi, donna modesta fuori dai circuiti della moda della capitale, traccia anche i suoi ori: «Molti sono i gioielli, portati solo dalla maritata salvo gli orecchini. Molti giri di catene d’oro lavorato e di perle vere che a volte raggiungono il numero di venti (Fig. 3). Medaglioni d’oro lavorato e tempestati di pietre preziose, coralli. Gli orecchini sono lavorati in oro e perle. Anelli d’oro ornati di incisioni, perle, ecc. Bracciale di oro massiccio (Fig. 4), con placche ben lavorate, ornate di perle, coralli, pietre preziose. Sul seno spilla d’oro lavorato e con pietre (Fig. 5)». Sempre a Luzzi, un altro rito locale prevedeva che i gioielli di famiglia fossero indossati anche dalla persona morta, esposta per l’ultimo saluto in una bara aperta, per essere poi recuperati, tuttavia, in modo discreto15.
Spesso i gioielli più diffusi a livello popolare avevano anche una funzione apotropaica o propiziatoria attraverso pietre ed elementi naturali, o attraverso particolari simbologie. La chiave era un amuleto terapeutico contro l’epilessia e l’emicrania e rappresentava il potere sul cuore dell’uomo; si trovava, inoltre, in antichi riti, insieme con altri oggetti, al capezzale dei morenti per alleviare la loro agonia e favorirne il trapasso. Il pesce era simbolo di salute e abbondanza anche nella tradizione partenopea, oltre a significare il Cristo; il serpente (Fig. 6) rappresentava l’Eternità e la buona salute. Secondo Raffaele Lombardi Satriani la sua pelle si strofinava sui capelli ai quali si legava come una fettuccia per impedirne la caduta e favorirne la crescita16; se si trovava nel letto portava fortuna, tanto che si metteva sotto il cuscino di un malato per favorirne la guarigione. Il serpente, che si credeva vivesse nelle viscere della Terra incamerandone le forze naturali, fu, infatti, considerato un simbolo positivo e consacrato a Esculapio, dio della medicina. La mezzaluna era un altro potente talismano che si rifaceva al condizionamento delle fasi lunari sui fenomeni rigenerativi della fertilità della donna e della Terra. Anche alla stella si davano poteri apotropaici, quando era a sei punte come nel sigillo di re Salomone. Queste sono solo alcune delle iconografie che si ritrovano nella gioielleria popolare calabrese insieme ai segni d’amore eterno, come l’edera, il nodo d’amore, il fiocco, la freccia di Cupido e il cuore. Altri segni richiamavano la purezza, la bellezza o la docilità della donna come la colomba, la farfalla (Fig. 7) e il cavallo con le redini a vista. Discorso a parte meritano le forbici, che un po’ aperte rappresentavano, come in alcuni paesi del Cilento, un monile contro le fatture e le maldicenze; potevano, però, indicare anche il taglio dei nastri verdi che legavano i capelli e il grembiule della nubile, prima che venissero sostituiti da quelli rossi nel rito della cerimonia che precedeva le nozze.
L’amuleto poteva essere costituito anche solo da pietre naturali, come il corallo che si donava ai bambini per proteggerli dall’itterizia e alle balie perché si credeva che il suo colore fosse indicatore della bontà del loro latte; sbriciolato, poi, poteva far conoscere il volto della futura moglie, ma era anche un antidoto contro i malviventi e contro i tifoni, era usato a scopo farmacologico o come moneta di scambio e gli si attribuivano mille altri poteri positivi17. Fino alla seconda metà dell’Ottocento si lavorava solo l’arboscello o cormo di colore rosso del Mediterraneo. Si pescava con una barca detta corallina dotata di un sistema che prevedeva l’immersione di una croce di legno con stralci di rete legati, detta ingegno, con cui scandagliare le acque. Dopo la significativa esperienza delle manifatture trapanesi18, perlopiù di origine ebraica, nel 1805 re Ferdinando IV diede al francese Martin una privativa decennale per aprire una fabbrica a Torre del Greco (Na) dove si formarono molti nuovi maestri che fornirono poi cammei, incisi e “liscio” a tutto il Regno borbonico, compresa la Calabria. Negli anni ’75, ‘78 e ‘80 dell’Ottocento al largo di Sciacca furono scoperti dei banchi di corallo per lo più decaduto, che in grande quantità entrarono nel mercato del Regno invadendolo con il loro colore salmonato così particolare. In ogni caso lungo le coste della penisola, dal versante ligure e tirrenico, passando da Imperia sino a Reggio Calabria e alle isole, vi si potevano trovare ancora molti banchi di corallo. Nel 1889 arrivò sul mercato italiano anche il Paracorallium japonicum. Questa specie del paese nipponico aveva numerose differenze dal rubrum: la sua forma non era un piccolo ramo rosso ma un ventaglio di più grandi dimensioni e presentava nuovi colori come il bianco sfumato in rosa, il cosiddetto “Pelle d’angelo”, il rosso scuro del “Moro”, o il rosso ciliegia del “Cerasuolo”. La grandezza dei rami era di un certo rilievo poiché i cespi raggiungevano 30-40 centimetri con un diametro di 160 millimetri. Questo portava a nuove possibilità di lavorazione e la delusione fu grande quando si accorsero della presenza di un’anima di colore contrastante, poco gradita alla moda ottocentesca, tanto che buona parte del ramo diventava materiale di sfrido.
Altro talismano era l’onice che, favorevole a Saturno, proteggeva i nati di sabato. Il suo colore nero ispirava, però, anche umiltà e si usava per realizzare corone da rosario e oggetti da lutto. La corniola, secondo Goethe, «Ti fa star felice e sano. Ti protegge dai malanni», mentre il granato era simbolo di fedeltà19. Le perle, così presenti sui gioielli calabresi, insieme alle madreperle e alle conchiglie, avevano il potere di trasmettere fertilità20.
Molti oggetti preziosi con queste simbologie, per lo più risalenti alla seconda metà dell’Ottocento, sono conservati in collezioni private e nelle raccolte provenienti dalle chiese dove adornavano sculture devozionali come ex voto. Si trovano, inoltre, in numerosi musei come nel Diocesano di Cosenza, nel Diocesano di Lametia Terme, nel Civico di Rende, nel Demologico di San Giovanni in Fiore e al Nazionale di Arti e Tradizioni Popolari di Roma21. Quest’ultimo museo si è costituito dopo la mostra di Etnografia Italiana del 1911, per realizzare la quale, diverse persone furono incaricate di reperire oggetti e gioielli tradizionali su tutto il territorio italiano. Questa ricerca non aveva lo scopo di inquadrare i ritrovamenti dal punto storico-artistico o in base alle manifatture di appartenenza, piuttosto il criterio era sulla particolarità e sull’aspetto curioso dei monili e gli oggetti furono riferiti al luogo in cui erano stati ritrovati. Anche l’attuale percorso museale etnografico evidenzia solo la data di acquisto di tali oggetti. In occasione di quell’esposizione romana di Arti e Tradizioni che commemorava i cinquant’anni della Repubblica, l’antropologo Raffaele Corso si occupò della Calabria e, attraverso uno studio dettagliato dei costumi, classificò le cittadine secondo il colore dominante degli abiti femminili22. Fra gli altri evidenziò come “abito nero” quello di San Giovanni in Fiore, conosciuto come u Ritùortu dal nome del copricapo bianco di lino ripiegato manualmente che copriva la capigliatura a treccine incrociate, e scendeva sulle spalle. Quest’abito, le cui origini risalirebbero al popolamento del casale nel 1600, era formato da una ricca e lunga gonna, un corpetto di velluto arabescato con maniche corte e larghe, una camicetta bianca e il copricapo (u ritùortu), ed era indossato in età da marito. In questa fase la ragazza riceveva pochi gioielli dalla famiglia poiché quelli della madre erano divisi fra i figli maschi. A Cosenza si preferiva indossare due gonne sovrapposte, spesso imbottite ai fianchi, in seta e raso con boleri ricamati in oro e bordati di merletti.
Anche il vestito faceva parte dell’eredità di famiglia, essendo realizzato in maniera artigianale con stoffe e rifiniture preziose, ricami, merletti, trapunte in oro e argento, madreperle e altri materiali che oltre a dare valore all’abito avevano anche un potere apotropaico. La tipologia dell’abito su cui sono portati i monili è molto importante, dato che questi si adattano alla moda delle acconciature e alle scollature delle vesti. I costumi tradizionali, differenziandosi, caratterizzano le donne e gli uomini delle piccole comunità. Compresa quell’antica albanese, che ha mantenuto i caratteri peculiari originari: sull’abito di gala o Arbereshe, le donne indossano un diadema ricamato con fili d’oro e d’argento (Keza) tenuto con nastri di seta e velluto; in alternativa portano un nastrino di velluto al collo con un pendente (Susti o Birloku) o la collana (Kanaka) con lunghe catenine d’oro, insieme alle spille (Spingulat) e agli orecchini (Riqinët). A parte per i nomi, questi oggetti sono così vicini a quelli indossati dalle ragazze del posto da chiedersi quanto possano aver influenzato le usanze territoriali e viceversa. Questa collettività resta, infatti, in linea con il pensiero dei Calabresi, tramandando fieramente le loro tradizioni di generazione in generazione.
Traspare chiaramente quanto la gente del posto tenga a difendere e preservare, nonostante i cambiamenti dei costumi, ritualità, simbologie e usanze altrove perdute per sempre. Tanto che nelle collezioni, non solo museali ma anche private, si trovano molti gioielli tradizionali per la maggior parte ottocenteschi (Fig. 8): oggetti in stile “Vittoriano”, genericamente detti in ambienti orafi napoletani “Borbonici”, anche se realizzati oltre la metà del secolo, o i successivi “Umbertini”, tutti prodotti principalmente a stampo. Questi gioielli popolari sono, prevalentemente, in oro rosso o giallo a bassa caratura con pietre a pasta vitrea e perle scaramazze, spesso fanno parte di parure o “parate”, come sono chiamate abitualmente. Legate a un gusto locale, caratteristico proprio solo dell’area calabrese, sono le collane in maglia leggera, realizzate a trina piatta o cilindrica con applicazione di placchette in oro rosso e giallo a bassa caratura dove spesso venivano agganciati montanti centrali rigidi con elementi fitomorfi e nappe leggere e “tintinnanti” a scopo scaramantico (Fig. 9). Collane simili, nel movimento con nappe laterali e fiocco, si trovano sia nel Tesoro della Cattedrale di Cosenza, sia al MNATP di Roma nella Raccolta Corso e De Chiara del 1909 (inventari 31164, 31280, 31281), molte provenienti da Catanzaro23. Un altro esemplare si può ritrovare al Museo civico di Rende (inv. 345), nella sezione folklorica “Raffaele Satriani Lombardi”, datato tra il 1890-9924. Oltre ai gioielli più tradizionali in alcune raccolte, come in quella della famiglia Spadafora e fra gli ex voto della Madonna del Rosario di Lametia, si ritrovano anche rare e leggerissime collane di fattura “Vittoriana” in oro giallo a bassa caratura, lavorato a stampo e rifinito a mano, a cesello e incisione (Fig. 10). Scrive Cavalcanti, che una tecnica molto diffusa in ambiente meridionale è quella dello stampaggio fatta con punzoni di bronzo o ferro, martelli o mazzole di legno, panetti di piombo per poggiare la lamina che prende la forma dallo stampo percosso; la rifinitura è a lima e cesoia25. Questo tipo di lavoro fu descritto come cosa saliente già da Lenormant, che vedendolo realizzare da un orafo a Catanzaro lo identificò come una tradizione antica del luogo per la produzione di gioielli di gusto popolare, leggeri e poco costosi, composti di sottili foglie d’oro stampate26 (Fig. 11). Alcuni esemplari della raccolta Spadafora (Fig. 12) hanno anche dei pendenti ad anforetta in stile sempre “Vittoriano”, che si ritrovano anche a Londra fra il 1835-40. In tutte le raccolte, ma in particolare in questa di San Giovanni in Fiore, sono presenti collier a maglie snodate, del tipo Bismark, Coda di topo, o Spiga di grano ma anche a Gourmette con pendenti realizzati per lo più a stampo e rifinitura manuale.
Le decorazioni richiamano in prevalenza elementi fitomorfi, ma si trovano anche simboli come pegni d’amore (nodo, colomba, farfalla, colomba, lira, fiocchi) (Fig. 13). Alcuni pendenti e spille a forma di “fiocco”, sono detti Sévigné ed erano già di gran moda nel XVII e XVIII secolo. Il nome deriva da quello della marchesa Marie de Rabutin-Chantal, Marquise de Sévigné (1626-1696). In origine era un semplice fiocco di stoffa indossato basso sul corpetto, in seguito divenne più elaborato, trasformandosi nel ’700 definitivamente in un gioiello. Un esemplare simile a pendente si trova nella Basilica di Maria SS. del Pettoruto a San Sosti. Fra queste catene non mancano gioielli tipici dell’Ottocento come i casca in petto o i saliscendi (Fig. 14) cui si applicavano monili e oggetti utili da tenere a portata di mano, compresi orologi da donna. A volte le casse a Savonette erano, però, solo finti orologi mostrati per vezzo.
Le lunghe collane che si regolano, dette sautoir, anche queste comparse già nell’Ottocento, continueranno ad essere di moda anche nel secolo successivo, insieme alla classica Collana Principessa (45-50 cm) e allo strangolino, aderente alla base del collo, che nell’età vittoriana, era visto piuttosto come oggetto del peccato e veniva indossato perlopiù da ballerine e prostitute. Molte collane hanno maglie traforate e leggere di moda all’inizio del Novecento; si ritrovano, infatti, nel catalogo del 1915 di A. Casartelli, una gioielleria, argenteria e orologeria che si trovava a piazza del Duomo a Milano27. Nella collezione Spadafora c’è anche una particolare Collana a forma di serpente a maglia snodata digradante, con applicazioni a targhette in oro rosso e giallo a bassa caratura, detta “tubogas”. La parte davanti del gioiello rappresenta un nodo da cui fuoriesce la testa del serpente in oro sabbiato, cesellato e inciso con pietre a pasta vitrea policroma incastonate all’inglese a castone ribattuto. Presumibilmente è di produzione napoletana degli anni Trenta. La serpe, simbolo del male ma anche di rigenerazione e fertilità, si ritrova già nei gioielli di metà XIX secolo anche snodata, mentre questo tipo di maglia è presente nei collier degli anni Quaranta come chaîne-serpent28 e appare in una pagina pubblicitaria di Van Cleef & Arpels sulla rivista “Vogue” del 1939. Questa maglia, in cui oro o acciaio sono lavorati a segmenti che rendono il gioiello flessibile per meglio adattarlo alla forma del collo e dei polsi, si ritrova, ma in una tipologia più semplice, anche nella raccolta degli ex voto della Madonna del Rosario di Lametia Terme. La sua lavorazione, ispirata a una tecnica artigianale dell’Ottocento, fu introdotta in gioielleria nel 1850 circa, ma divenne più celebre con Bulgari nel primo Dopoguerra proprio come “tubogas”. Molto antica e diffusa era, invece, la jannacca, o chianacca realizzata a vaghi vuoti e leggeri decorati a filigrana (Fig. 15). Secondo Domenico Pisani29, il suo nome potrebbe derivare dall’ebraico canac con riferimento alle manifatture orafe israelitiche presenti sul territorio. Nel nord della Calabria questa collana presentava vaghi di lavorazione diversa, che potevano essere a cocciu d’olivu, a grani pieni o vuoti decorati a fili d’oro, mentre quelli cosiddetti a conocchia, per la somiglianza con lo strumento per filare, avevano vaghi in forma ovale in filigrana e perline scaramazze lungo la circonferenza. In molti paesi come San Giovanni in Fiore, questo era il gioiello più importante per la donna maritata insieme alla “perna” realizzata con vari fili di perline scaramazze, e ai girocollo in vellutino con un pendente chiamati brilloccu, dal francese breloque, noto nel meridione anche con altre definizioni. I Lazzu erano semplici catene d’oro di varie lunghezze, anche con maglie intervallate da pietre. Mentre il “cuncìertu” era un gioiello formato da più catene tenute insieme da un medaglione, le cui parti potevano essere divise e utilizzate in modo diverso, se ne trovano esemplari esposti al Museo di Arti e Tradizioni di Roma proprio nel settore dedicato alla Calabria30.
A San Giovanni la tradizione voleva che i gioielli fossero divisi fra i maschi della famiglia: al primogenito spettava la “jannacca”, mentre la “Perna” a fili di perline scaramazze era divisa in parti uguali. Alle femmine spettava solo un ricordo della madre. In caso di morte del marito la donna rinunciava ai suoi gioielli e portava solo orecchini e spille dai toni scuri. Raro l’uso del corallo e della tartaruga. Non si ritrovano in gran numero neanche i bracciali, anche se ben ventiquattro, fra fine Ottocento e inizio Novecento, a fascia con decorazioni a smalto e pietre, a sinaculi (vaghi filigrana leggeri e vuoti) o a gourmette, si rinvengono nella raccolta degli Spadafora. Sono presenti, in un discreto numero, bracciali dello stesso periodo anche come ex voto donati alla statua della Madonna del Rosario della chiesa di San Domenico a Lametia Terme-Nicastro (Fig. 16), custoditi dalla congrega intitolata proprio alla Madonna. I bracciali rientrano in quella gioielleria che già a partire dalla fine del Settecento guardò alle istanze romantiche e cercò ispirazione nel passato rivolgendosi al Rinascimento e al Medioevo prima, e poi alle antiche civiltà greche, etrusche e romane, seguendo un’inclinazione di revival che divenne dominante almeno fino agli anni Trenta dell’Ottocento, riaffiorando però durante tutto il secolo. L’Ottocento rimane, infatti, in ogni caso il secolo dell’eclettismo che a volte può diventare approssimazione per mancanza di un supporto documentario. I bracciali a mezzo cerchio proliferarono dal 1870 in poi. Il semplice motivo del cerchio con cerniera e fermaglio, e con la decorazione limitata alla parte visibile, si prestava a numerose varianti, alcune anche molto elaborate con motivi a disegni floreali e a entrelac de rubans. La serie con nodi d’amore, chiusure, anelli, catene e frecce di Cupido richiamava al nodo indissolubile della promessa matrimoniale. Molto diffusi in tutta la penisola ma più ricchi nel meridione, i bracciali a vaghi leggeri, formati da due coppe stampate e poi saldate, furono realizzati già dagli Etruschi con motivi decorativi a filo d’oro mentre i Romani preferivano quelli impressi.
A differenza dei bracciali gli Spilloni con elementi decorativi naturalistici (cavalli, lira, cuori, nodi, chiavi…) erano molto diffusi sul territorio anche perché avevano il fine pratico di tenere fermi veli e copricapo. Le spille in oro a bassa caratura che si ritrovano nelle raccolte locali, per lo più di Otto-Novecento, erano formate, prevalentemente, da una serie di parti a stampo assemblate: cannule vuote, modanature sbalzate, fiori traforati, pietre a pasta vitrea policroma. La collezione Spadafora conserva anche numerosi spilloni in ebano utilizzati dalle donne in periodo di lutto quando la donna rinunciava a tutti i gioielli, persino alla Jannacca se la morte riguardava il coniuge, ma continuava a indossare spille e spilloni in materiali scuri come l’ebano e la tartaruga. La varietà dei tipi all’interno della raccolta, ci indica quanto a lungo fosse continuata questa tradizione e come questo oggetto fosse ritenuto una parte significativa della “parata”, ossia dell’insieme di gioielli della donna sposata (Jannacca, perna, spille e spilloni, e orecchini).
Restano nelle raccolte anche numerosi gioielli con decorazioni a pasta vitrea, spesso di colore verde o rosso per indicare lo stato di nubilato o di matrimonio delle donne. Altri hanno, invece, decorazioni a smalto che rientrano ne “l’oro dell’emigrante”, donato alla sposa prima della partenza, con alcune iniziali (Amor, Ricordo, Souvenir).
Abbiamo quindi, in linea di massima una vasta rappresentanza di gioielleria popolare con oro a 8 o a 12 o a 14 carati, smalti e pietre non preziose, memoria di una parte della società spesso dimenticata o non considerata le cui manifestazioni sono state, in alcuni casi, addirittura cancellate e che qui fortunatamente hanno mantenuto il loro valore originario. Fra gli oggetti più strettamente legati al costume tradizionale femminile, si ritrovano anche, in grande varietà, gli anelli, per antonomasia simbolo dell’unione matrimoniale. La loro decorazione può avere vari simboli, come due palmi di mano che si stringono, da cui il termine impalmare, cuori, nodi, chiavi, colombe o cani, a rappresentare purezza, fedeltà o un vincolo indissolubile. Queste tipologie sono comuni nella cultura popolare del centro-meridione, ma gli anelli con doppia spola e doppia foglia sono più tipici della Calabria e della Puglia.
Molto frequenti in area meridionale sono anche gli anelli a fiore e a rosa, mentre la decorazione con ramage naturalistici, detta “a giardinetto”, deriva da una produzione siciliana. Oltre quelli a bottone, a spola, a rombo, a stella e a cuore, si trovano anche anelli a “fiocco” con una pietra centrale e altre a gruppi laterali. In Calabria spesso la decorazione è con perline scaramazze, simbolo di fertilità.
Resta un caso a parte quello degli orecchini che venivano indossati anche dalle nubili e dagli uomini per il potere che si attribuiva loro di rafforzare la vista. Anche i marinai bucavano il lobo per introdurvi delle buccole d’oro “per schiarirsi la vista”. Gli orecchini in Calabria sono descritti da R. Corso a inizio Novecento (ricchini, vucculergi, pindagghi) come pendagli grossi e lunghi detti li fioccaglie di varie fogge, che figuravano anche nel costume tradizionale contadino della provincia di Reggio31. Nelle ritualità di alcuni paesi, come Luzzi, se ne trovavano documentati negli accordi matrimoniali di tre tipi: a cerchio, lunghi e piatti (Fig. 17) con una frangia a fili d’oro, a ra moda (alla moda), a rugétta concavi e di forma quasi ovali con tre pendenti più piccoli. Alcuni cerchi sono detti “a Palombella” perché presentano delle rosette incatenate all’interno (Fig. 18). Altri si dicono a navicella per la forma a barca, ma quelli più comuni sono a mandorla, con il gancio che lega tutto il ciondolo allungato o a goccia con bottone e pendaglio. Il pendente può essere a nappa, a torciglione, a goccia, a più gocce e a grappolo d’uva. A volte questi pendenti sono così leggeri e vuoti che danno l’idea di tintinnare e hanno un valore anche apotropaico. Anche gli agganci variano: quello più antico è ad amo, ed è detto alla “Pompeiana”, l’aggancio con una cerniera che chiude davanti, è detto “a monachella” (Fig. 19), mentre quello più recente a barra con anellino retrostante è detto “alla napoletana”. Anche in questo caso notevole è la presenza di perline scaramazze come motivo decorativo insieme con altre pietre o cucite a pavè con filo d’oro su un’intelaiatura a forma di foglia (Fig. 20). Oltre alle perle si riscontra anche la presenza dell’opalina di gran moda fra il 1868 e 1873. Negli ambienti non popolari, la moda delle perle a più fili fu lanciata dalla Regina Margherita di Savoia che ne portava a molti giri, e ogni anno ne riceveva uno in dono dal consorte a Natale. Lei usava smontare i suoi gioielli per inventarne degli altri in cerca di un nuovo stile “Italiano”. La Regina e la sua corte avranno un certo successo non solo sulla penisola ma in tutta Europa già dal 1870, anno del suo matrimonio con il principe Umberto.
Ritornando all’orecchino, per quello che riguarda la tipologia a pendente, spesso smaltato, ritornò in voga nel 1865 dopo anni di assenza; del resto da questo momento cambia anche la moda delle acconciature e dei cappelli che diventarono più piccoli dando maggiore visibilità ai lobi delle orecchie. Dal 1890 per un quinquennio la moda divenne, invece, più lineare e la donna più filiforme, ma poi ritornò ad abiti a vita stretta con maniche gonfie e gonne scampanate su cui si potevano indossare, al collo, nastri di velluto con pendagli. Solo a fine secolo lo stile devierà verso una maggiore severità fatta di colletti alti e rigidi, colori scuri e linee verticali che attenuavano le curve. Per questo motivo gli orecchini, che nel 1880 erano prevalentemente pendenti, dopo il 1890 diverranno un bottone al lobo dell’orecchio con una chiusura a gancetto.
Altri gioielli molto diffusi a livello popolare sono le Spingude che servivano per fermare i copricapo (“u ritùotu” a San Giovanni in Fiore) e i Fermagliudi, ossia le spille che erano appuntate sul corpetto. Su quest’ultimo, detto incùllerata, si appuntavano anche delle spille a barretta con smalti, dette tradizionalmente Matrò o Motrò per la presenza di una miniatura con volto femminile. Queste miniature, dette genericamente “Figurini” (Fig. 21), sono un’altra particolarità del territorio: erano dipinte con volti di donna su avoriolina o più spesso a smalto con l’aiuto di matrici, creando, con elementi arginanti in oro, e spesso, piccole pietre incastonate, un effetto che ricordava il cloisonné. In linea di massima erano come bottoni rotondi, dai volti ripetitivi, che erano applicati su varie tipologie di gioielli. Il loro stile e la mancanza, a oggi, di una documentazione sulla manifattura originaria che risulta misteriosa e sconosciuta, ha fatto affiorare la concreta ipotesi che siano stati realizzati altrove e assemblati da orafi locali. Per dare una dimensione di questo fenomeno, basti pensare che in contrasto con le decine e decine di “Figurini” dallo stesso stile, presenti in area soprattutto cosentina su gioielli di fine Otto e inizio Novecento, se ne ritrovano, fino ad ora, solo alcuni a Napoli e uno su un anello conservato nei depositi del Museo di Arti e Tradizioni popolari di Roma sempre di provenienza calabrese32. A mio parere, le notizie tramandate ma non documentate che vogliono che queste miniature siano state realizzate in paesi di cultura tedesca possono essere nate dalle loro iconografie, che riprendono costumi della tradizione rinascimentale del Nord-Europa o orientaleggianti. Questi temi, però, si rifanno a una tendenza diffusa in campo artistico già a partire dagli anni ’40 dell’Ottocento quando, in pittura e scultura, si illustravano ricostruzioni storico-letterarie e romantiche riproducendo costumi originari delle Nazioni d’Oltralpe o luoghi esotici. Fra i tanti autori che contribuirono a diffondere questa linea, dettata anche in un primo momento da motivi politici, si veda Domenico Morelli (Torquato Tasso legge la Gerusalemme liberata a Eleonora d’Este, 1865; La moglie di Putifarre, 1864; Il Bagno Turco; Gli ossessi, 1873-76; Maometto prega con i soldati nel deserto; l’Improvvisatore arabo, La sultana e le schiave al ritorno dal bagno, l’Odalisca); Achille della Croce (Pia de’Tolomei, 1863); Alfonso Balzico (Cleopatra); Achille d’Orsi (l’Idolo, il Salvator Rosa, 1871-80; I Parassiti, 1877), Giovan Battista Amendola (Caino e la sua donna, 1877), fino a Filippo Cifariello (Fachiro 1895). Come s’intuisce già solo dai titoli delle opere, questi artisti illustrarono proprio figure storiche o esotiche, spesso frutto di fantasia, diffondendo una moda che interesserà poi anche i gioielli33. Le miniature calabresi, omogenee nel disegno e nella realizzazione, pur nella diversità degli autori, potrebbero essere state prodotte anche a Napoli, dove ancora a inizio Novecento erano tanti i laboratori in grado di realizzare questo tipo smalto. Purtroppo la maggior parte di questi artisti-artigiani rimangono nell’oblio perché manca una documentazione sulle loro produzioni. Uno dei pochi su cui è stata focalizzata l’attenzione è Vincenzo Miraglia, orafo e argentiere napoletano ricordato come moderno innovatore nell’arte proprio dello smalto. Egli già nel 1891 presentò all’Istituto d’incoraggiamento di Napoli opere a 18 carati smaltate, che furono molto apprezzate dalla Commissione sia dal punto di vista tecnico sia artistico. Negli Atti si legge: «Fra i lavori tutti pregevoli, quelli che hanno richiamato la nostra attenzione sono quelli a smalto, la cui fattura specialmente per il grado di perfezionamento ottenuto, non potrebbe essere considerata come una manifattura napoletana, sebbene come prodotto delle migliori fabbriche francesi, tenuto conto di quanto si opera attualmente da noi….»34. Fu premiato con la medaglia d’argento del grande conio e se anche il suo genere naturalistico è lontano dalle miniature calabresi, vicine a uno stile bozzettistico e veloce, nulla ci vieta di ipotizzare che da fine Ottocento si formassero attorno al suo successo, delle botteghe che aderendo a questa moda, la estendessero anche a un gusto più popolare. Per quanto la documentazione e le notizie siano piuttosto scarse, a inizio secolo c’erano, infatti, diversi laboratori nel borgo degli orefici a Napoli dove si realizzavano piccoli smalti e miniature su avoriolina. Sono, in ogni caso, lavori delicati, legati alla moda del momento e non se ne trovano oggi in città che pochi esemplari, anche se della identica serie di quelli calabresi. Questi piccoli dipinti, invece, insieme alla maglia a trina aurea piatta o a torchon, diffusa soprattutto a Cosenza e Catanzaro, e alle scaramazze caratterizzano le collezioni della Calabria, sia quelle private sia quelle museali.
La tradizione orafa è, infatti, ancora molto diffusa sul territorio e molti sono i nomi di famiglie che si sono dedicate a quest’arte. Si pensi ad Antonio e Gennaro Perri, che si formarono nella bottega del padre Alberto nato nel 1907 e del nonno nato nel 1868, i cui gioielli si trovano nel Museo Civico di Rende o a Gerardo Sacco nato nel 1940 a Crotone, tutti interpreti della cultura locale rivisitata dal loro estro. Fra le raccolte private spicca quella del maestro Giovan Battista Spadafora di san Giovanni in Fiore, che ha un’impresa di famiglia per la lavorazione e commercializzazione di gioielli e oggetti in oro e argento, comprese le corone per statue processionali e oggetti votivi35. Nato nel 1938, apprese i primi rudimenti di quest’arte dal padre, Giuseppe nato nel 1913 e dallo zio, Antonio Pasquale, del 1910, i quali, a loro volta, avevano imparato dal padre Francesco nato nel 1882. La ricostruzione della bottega di Francesco Spadafora si trova esposta nel museo Demologico di San Giovanni in Fiore dove ci sono anche numerosi esempi di strumenti artigianali di settore e gioielli popolari. Gli Spadafora, nel corso degli anni, hanno conservato e collezionato molti esempi di gioielli popolari e tramandato antiche tecniche, come quelle delle lamine di oro ricavate da stampi. Proprio grazie alla loro profonda conoscenza ed esperienza lavorativa hanno formato, infatti, una collezione di più di quattrocento gioielli popolari dalla metà dell’Ottocento ai primi anni del Novecento (Fig. 22). In molti di questi oggetti si percepisce il gusto del territorio, ma anche altre tipologie che spiegano i rapporti commerciali con la Capitale del Regno di cui riproponevano anche la moda in uno scambio proficuo: si veda per questo, l’orecchino a forma di foglia d’edera ricoperto da perline cucite a filo d’oro o i monili in filigrana che però in Calabria divennero più semplificati e sobri. C’era un utilizzo più parco anche delle pietre semipreziose, coralli e smaltature, in uno stile sintetico e lineare distante da certi effetti vistosi dei territori vicini. Tendenza che, grazie all’attitudine conservatrice dei luoghi, ha avuto lenti mutamenti nel tempo.
- Desidero ringraziare la famiglia Spadafora, Pasquale Lopetrone, Milena Lopez, il Museo Demologico di San Giovanni in Fiore, Francesco Abbate, Maria Concetta Di Natale, Roberta Cruciata, Mario Panarello, il Museo Diocesano di Arte sacra della Diocesi di Lametia Terme, Paolo Francesco Emanuele, Marta Petrusewicz, Roberto Sottile, il Museo Nazionale di Arti e tradizioni popolari di Roma, Filippo Maria Gambari, Mario Mineo e Gabriella Manna. [↩]
- Si veda A. Lipinsky, Schede bibliografiche per la storia dell’arte orafa in Calabria, in «Brutium», N S, vol. II, 1970, n. 4. p. 3; Idem, recensione per Note su due croci d’argento del sec. XVII di B. Cappelli, in «Archivio Storico per la Calabria», a III, 1933, pp. 539-40; Idem, Studi e ricerche sull’antica oreficeria italiana, in «Calabria Nobilissima», a II, 1948; Idem, Oreficeria e argenteria in Europa, dal XVI al XIX secolo, Novara 1979; E. La Pera, Enciclopedia dell’Arte di Calabria. Ottocento e Novecento, Soveria Mannelli (Cz), 2008; Oreficeria popolare italiana. Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni popolari, Roma 1964; Gioielli in Italia. Il gioiello e l’artefice. Materiali, opere, committenze, atti del convegno a cura di L. Lenti, Venezia 2005; R. Romano, Collezione ori antichi. Famiglia Spadafora, maestri orafi di San Giovanni in Fiore, Soveria Mannelli (Cz), 2017. [↩]
- A. Lipinsky, Scuole argentarie in Calabria Citra, in «Almanacco Calabrese», 1972-73, pp. 157-69; Idem, Calici per Gioacchino da Fiore. L’argenteria e gli argentieri di Longobucco alle origini di una scuola orafa in Calabria Citeriore, in Atti del Congresso Nazionale di Studi Danteschi, Firenze 1975, pp. 189-207; Argenti di Calabria, testimonianze meridionali dal XVI al XIX secolo, Napoli 2006; P. Lopetrone, La chiesa abbaziale Florense di San Gioacchino in Fiore, San Giovanni in Fiore (Cs) 2003. [↩]
- O. Cavalcanti, Ori antichi di Calabria, Palermo 1991, p. 16. È nota, inoltre, la grande tradizione orafa in alcuni paesi di cultura albanese radicati sul territorio calabro come Carfizzi (Cz), per cui cfr. Ivi, pp. 17, 69; L’Ornamento Prezioso. Una raccolta di oreficeria popolare italiana ai primi del secolo, catalogo della mostra a cura di P. Ciambelli, Roma Museo delle Arti e Tradizioni Popolari, Roma-Milano 1986; R. Corso, Taccuini manoscritti per la Mostra Etnografica Italiana, Roma, Museo Nazionale di Arti e Tradizioni Popolari, 1911; Idem, Pittacium. La nota del corredo nei contratti nuziali calabresi, in «Rivista italiana di Sociologia», a XXV, fascicoli I-II, 1921; idem, L’oreficeria popolare italiana in «Calabria Letteraria», a VIII, 1960, nn. 5-7. [↩]
- R. Filangieri, I Registri della Cancelleria Angioina, III, 1269-70, Napoli 1951, p. 201. [↩]
- A. Lipinsky, Le Arti minori, in «Almanacco Calabrese», a. VII, 1957, p. 36. [↩]
- C.G. Bulgari, Argentieri, gemmarie orafi d’Italia, Roma 1958, vol. I, p. 182. [↩]
- O. Cavalcanti, Ori antichi…, 1991, p. 16. [↩]
- Dal 1823 come bollo per Cosenza fu scelto una C, mentre a Catanzaro il saggiatore Giuseppe La Gamba usò un punzone a stella. [↩]
- E. e C. Catello, Argenti napoletani dal XVI al XIX secolo, Napoli 1972, pp. 158-159. [↩]
- G. Sole, Viaggio nella Calabria Citeriore dell’800, Cosenza 1985 [↩]
- O. Cavalcanti, Ori antichi…, 1991, p. 23, n. 21. [↩]
- Furono presentate lettere di protesta all’intendente di Calabria Citra con acclusi vari documenti di nomina e il certificato di cui si è detto a firma degli orefici cosentini (Raffaele Cimbalo, Pietro Palmieri, Luigi Marrazzo, Luigi Di Caro, Francesco Martino Sagiato, Francesco Puntieri, Vincenzo Parisio e Antonio Maida), per cui si veda Ivi, pp. 21, 35. Il Monte di pietà di Cosenza era stato fondato il 19 aprile del 1564 dai nobili della Confraternita del SS. Sacramento. [↩]
- Nel 1934 pubblicò per i caratteri della Sperling e Kupfer di Milano Il costume popolare in Italia, una raccolta di bozzetti sull’abbigliamento regionale. [↩]
- D. Pisani, Il gioiello popolare calabrese, Napoli 1997, pp. 17-18; Cosenza Preziosa, L’Arte orafa tra il XIX e il XXI secolo a cura di D. Pisani, Soveria Mannelli (Cz) 2005. [↩]
- R. Lombardi Satriani, Credenze popolari calabresi, Messina 1970, p. 55. [↩]
- Per il corallo e la sua simbologia si veda M.C. Di Natale, Il corallo da mito a simbolo nelle espressioni pittoriche e decorative in Sicilia, in L’Arte del corallo in Sicilia, catalogo della mostra a cura di C. Maltese e M.C. Di Natale, Palermo 1986, pp. 79-107. [↩]
- Per questo argomento si rimanda a M.C. Di Natale, I cammei in corallo del Museo Pepoli, in Miscellanea Pepoli. Ricerche sulla cultura artistica a Trapani e nel suo territorio, a cura di V. Abbate, Trapani 1997; Eadem, Gli epigoni dell’arte trapanese del corallo: i monili dell’Ottocento, in Gioielli in Italia. Temi e problemi del gioiello italiano dal XIX al XX secolo, atti del convegno a cura di L. Lenti e D. Liscia Bemporad, Venezia 1996, pp. 59-64; Eadem, Coralli siciliani a Novara, in «Kalós. Arte in Sicilia», a. 12, n. 2, Aprile – Maggio 2000; Eadem, Gioielli di Sicilia, Palermo 2000, II ed. 2008; Eadem, Oro, argento e corallo tra committenza ecclesiastica e devozione laica, in Splendori di Sicilia. Arti decorative dal Rinascimento al Barocco, catalogo della mostra a cura di M.C. Di Natale, Milano 2001, pp. 22-69; Eadem, I maestri corallari trapanesi dal XVI al XIX secolo, in Materiali preziosi dalla terra e dal mare nell’arte trapanese e della Sicilia occidentale tra il XVIII e il XIX secolo, catalogo della mostra a cura di M.C. Di Natale, Palermo 2003, pp. 23-56; Eadem, Ars corallariorum et sculptorum coralli, in Rosso corallo. Arti preziose della Sicilia barocca, catalogo della mostra a cura di C. Arnaldi di Balme, S. Castronovo, Cinisello Balsamo 2008, pp. 17-33; Eadem, L’arte del corallo a Trapani, in Mirabilia coralii. Capolavori barocchi in corallo tra maestranze ebraiche e trapanesi, catalogo della mostra, a cura di M.C. Di Natale, C. Del Mare, Torre del Greco 2011, pp. 54-87; Eadem, I coralli della Santa Casa di Loreto, in Sicilia ritrovata. Arti decorative dai Musei Vaticani e dalla Santa Casa di Loreto, a cura di M.C. Di Natale, G. Cornini, U. Utro, catalogo della mostra, Palermo 2012, pp. 109-132; Eadem, Ad laborandum corallum, in I grandi capolavori del corallo. I coralli di Trapani del XVII e XVIII secolo, catalogo della mostra a cura di P. Li Vigni, M.C. Di Natale, V. Abbate, Milano 2013, pp. 39-55; Eadem, Apotropaici gioielli di corallo, in Vestir las joyas. Modas y modelos, atti del convegno, Madrid 2015, pp.293-302; Eadem, Orafi, argentieri e corallari tra committenti e collezionisti nella Sicilia degli Asburgo, in Artificia Siciliae. Arti decorative siciliane nel collezionismo europeo, a cura di M.C. Di Natale, Milano 2016, pp. 15-61. Si veda anche R. Romano, Opere di trapanesi nella collezione Liverino di Torre del Greco: alcune aggiunte inedite, in Itinerari d’arte in Sicilia a cura di G. Barbera e M.C. Di Natale, Edizioni Milano 2009, pp. 380-387, 523-525 e R. Cruciata, Capolavori trapanesi in corallo del XVII e del XVIII secolo a Malta, in «OADI. Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia», a. 4 n. 8, Dicembre 2013, pp. 43-62. E ancora B. Liverino, Il corallo. Esperienze e ricordi di un corallaro, Torre del Greco (Na), 1983; A. Putaturo Murano, A. Perriccioli Saggese, L’arte del corallo. Le manifatture di Napoli e Torre del Greco fra Ottocento e Novecento, Napoli 1989; F. Balletta, C. Ascione, I Gioielli del mare, Napoli 1992; Rosso corallo. Due secoli di coralli e cammei di Torre del Greco, a cura di C. Ascione, Torre del Greco (Na) 1998; G.C. Ascione, Il corallo a Napoli. Storia di un collezionismo tra viceregno e regno, in Splendori di Sicilia…, 2001, pp. 100-107. [↩]
- O. Cavalcanti, Ori antichi…, 1991, pp. 88-92. Si veda anche R. Corso, Amuleti contemporanei calabresi, in «Revue des études éthnographiques et sociologiques», Parigi 1909; Idem, Pittacium. La nota del corredo nei contratti nuziali calabresi, in «Rivista Italiana di Sociologia», a XXV, fasc. I-II, 1921; F.S. Meligrana, Donne, oro e monili in un universo contadino, in Donne e Società, atti del IV congresso internazionale di studi antropologici siciliani a cura di J. Vibaek, Palermo 1987. [↩]
- Si veda in proposito M.C. Di Natale, Gioielli…, II ed. 2008, passim. [↩]
- Per l’argomento si veda L’Ornamento Prezioso…, 1986, con bibliografia precedente. [↩]
- Si veda R. Corso, Taccuini manoscritti…, 1911. [↩]
- Oreficeria Popolare italiana…, 1964, pp. 9, 43, tav. 54; L’Ornamento prezioso…, 1986, p. 182, n. 382, tav. 79; O. Cavalcanti, Ori antichi di Calabria…, 1991, p. 171, tavv. 121, 124, invv. 31280, 31281; D. Pisani, Cosenza Preziosa…, 2005, pp. 52-53. [↩]
- D. Pisani, Il gioiello popolare calabrese…, 1997, pp. 34-35 e anche pp. 64-65. [↩]
- O. Cavalcanti, Ori antichi di Calabria…, 1991, pp. 27-31. [↩]
- Francois Lenormant, (Parigi 1837-83) visitò la Calabria nel 1879. F. Lenormant, La Grande Grèce, paisages et histoires, vol. III, La Calabrie, Paris, 1881; La Magna Grecia, trad. di A. Lucifero, Chiaravalle C.le, Frama Sud, 1976, pp. 312-313. [↩]
- A. Casertelli Milano. Gioielleria oreficeria argenteria orologeria, catalogo semestrale n. 34, 1 marzo MCMXIII, a. XIII. [↩]
- Si vedano, ad esempio, le creazioni di questi anni di Mellerio, Van Cleef & Arpels e Tiffany. [↩]
- D. Pisani, Il gioiello popolare calabrese…, 1997, pp. 18-19. [↩]
- O. Cavalcanti, Ori antichi di Calabria…, 1991, p. 171, n. 125, tav. 125, inv. 31149. [↩]
- L’Ornamento prezioso…, 1986, pp. 178-179, nn. 320, 342, 343, ma anche Raccolta Guzzolini del 1910, n. 338, inv. 31201 e Raccolta De Chiara, 1906, n. 334, inv. 31206. [↩]
- L’Ornamento prezioso…, 1986, p. 182, n. 380. [↩]
- Cfr. Domenico Morelli e il suo tempo, 1823-1901, dal romanticismo al simbolismo, catalogo della mostra a cura di L. Martorelli, Napoli 2005; R. Romano, Achille Della Croce, Pia de’ Tolomei; Achille d’Orsi, L’Idolo; Achille d’Orsi, I Parassiti e Testa di parassita, in Il Bello o il Vero, la scultura napoletana del secondo Ottocento e del primo Novecento, catalogo della mostra a cura di I. Valente, Castellammare di Stabia (Na) 2014 pp. 175, 208-209, 242-244; I. Valente, Giovan Battista Amendola, Caino e la sua donna, in Il Bello o il Vero, 2014, pp. 199, 210-213, 237-241; L. Martorelli, Filippo Cifariello, Il Fachiro, in Il Bello o il Vero, 2014, pp. 280-81. [↩]
- R. Capuano, Appunti per una storia dell’arte orafa napoletana fra Ottocento e Novecento: sulle tracce di Vincenzo Miraglia, in Gioielli in Italia. Tradizione e novità del gioiello italiano dal XVI al XX secolo, atti del convegno a cura di L. Lenti e D. Liscia Bemporad, Venezia 1999, pp. 121-134. [↩]
- D. Pisani, Spadafora, in Dizionario del Gioiello Italiano del XIX e XX secolo, a cura di L. Lenti e M.C. Bergesio, Torino 2005, p. 261. [↩]