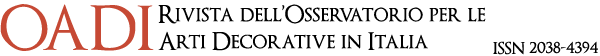jeeg81@hotmail.it
“Reca stupore al tempo” – Riflessioni sui tabernacoli in lapislazzuli a Palermo tra tarda maniera e neoclassicismo
DOI: 10.7431/RIV14042016
Nella Palermo di fine Cinquecento, all’interno di una sedimentata attività sacra, che avrebbe coinvolto nella realizzazione di apparati liturgici numerosi artisti tra architetti, pittori, scultori e maestri orafi, la Compagnia di Gesù, in ottemperanza alle nuove direttive di Carlo Borromeo1, si era mostrata particolarmente attenta nello sviluppare questo genere di strumento di apostolato2. I Gesuiti, difatti, sarebbero stati i veri ideatori del monumentale ciborio3 collocato sull’altare maggiore delle loro chiese; questo allestimento raggiunse una sorta di “spettacolarizzazione” e di perfezione tecnica tale da spingere l’Ordine a cimentarsi e a formulare nuove soluzioni applicative, elaborando idee progettuali inerenti, da una parte, alla dimensione puramente mistica derivante dalla pratica degli Esercizi Spirituali di Ignazio di Loyola, dall’altra da un percorso didattico.
L’attenzione per il dogma della transustanziazione dava origine a una varietà di configurazioni e stimolava la complessa evoluzione tipologica subita dall’altare favorendo così la costruzione di ricche e magniloquenti architetture in legno, marmo o metallo sugli altari maestri delle chiese, divenendo dei veri e propri oggetti d’oreficeria a scala monumentale per custodire ed esporre dignitosamente il Corpus Christi4.
Accanto alla produzione architettonica e pittorica avviata dai Gesuiti di Palermo, l’intagliatore di origini toscane, Bartolomeo Tronchi (1529-1604)5 – secondo una consolidata tradizione gesuitica –realizzava verosimilmente a Roma il ciborio per il presbiterio del Gesù di Palermo (oggi andato perduto ad eccezione del Crocefisso recante la data 1588 che doveva ornarne la sommità)6.
L’opera, stando alle parole del gesuita Pietro Pirri, sopraggiunse a Palermo scomposta in diverse parti per essere in seguito assemblata direttamente dallo stesso artista, che a tal scopo, raggiungeva il capoluogo siculo nell’ottobre del 15877.
Attraverso l’ausilio di alcuni disegni seicenteschi (Fig. 1) è possibile oggi avere un’idea ben precisa del ciborio del Gesù di Palermo e inoltre, indagarne i processi costitutivi e progettuali per le varie tipologie di tabernacoli (o cibori) pensati all’interno dello spazio ecclesiale controriformato.
La prima descrizione di questa suggestiva opera viene espressa dall’erudito Valerio Rosso, il quale nel 1590 così scriveva: Nell’altare maggiore vi è un tabernacolo dorato, di altezza più di tre canne, il quale venne da Roma, ed è il più bello non solo della Sicilia, ma anco di tutta l’Italia: poiché è adorno delli dodici apostoli in rilievo, ed in mezzo vi è una chiesa con sue colonne, e da canto alcune figure del Testamento vecchio8 .
L’assetto scenografico del ciborio palermitano evidenziava una stretta connessione con gli apparati allestiti in occasione delle Quarantore, ufficio liturgico introdotto dagli stessi Gesuiti, presso i quali l’orazione avrebbe assunto i segni di un sontuoso “spettacolo sacro”, offrendo ai fedeli la possibilità di ammirare l’esposizione solenne del SS. Sacramento con grandiosi apparati realizzati attraverso innovative soluzioni scenografico-illusionistiche.
Si deve fare però una distinzione di base tra apparati liturgici e apparati effimeri per le Quarantore. All’interno delle indicazioni promosse dalla Compagnia di Gesù è importante ricordare che, in qualunque campo artistico, si svilupparono fin dall’inizio due strade ben distinte, ma che nel prosieguo si potevano allo stesso modo intersecare. Spiritualità e didattica costituirono l’ossatura primaria di ogni iniziativa gesuitica, all’interno della quale si sarebbe composta tutta la loro produzione artistica e culturale. Gli apparati per le Quarantore, di conseguenza, appartenevano a una dimensione spirituale ben più specifica poiché si ponevano quale strumento di preghiera per i fedeli, una volta superato l’impatto di meraviglia e stupore data da una tale visione scenografica.
Non sappiamo nello specifico con quali materiali fosse stato realizzato il ciborio del Gesù di Palermo, ma possiamo dedurre che esso ad ogni modo potesse essere stato conseguito con un rivestimento in pietre dure e semipreziose o in marmi policromi. Tale manufatto recava una qualche affinità tipologica con il tabernacolo realizzato da Domenico Fontana, Sebastiano Torrigiani e dal siciliano Lodovico Del Duca per la cappella del SS. Sacramento in Santa Maria Maggiore a Roma9. La tipologia a frontale architettonico unita al tipo “a tempietto” ha per quest’ultimo disegno un altro simile referente, il tabernacolo eucaristico in San Giovanni in Laterano, sempre a Roma, realizzato da Pompeo Targoni tra il 1597 e il 160010. Le analogie strutturali si riferiscono alle monumentali cappelle papali. Tale operazione decorativa, di rilevante significato e notorietà, eseguita tra i pontificati di Sisto V, Clemente VIII e Paolo V, includeva le iniziative artistiche per il Giubileo del 1600. Il riferimento a note tipologie in uso a Roma era stato molto frequente nella cultura artistica siciliana, anche per la commissione di dipinti e per l’intervento di architetti e scultori continentali in servizio presso gli Ordini religiosi.
Un’opera di straordinario interesse per un tentativo di delineare le coordinate di fondo nella evoluzione dei tabernacoli realizzati in pietre dure e nello specifico in lapislazzuli a Palermo è costituita dal tabernacolo (Fig. 2) ordinato dall’arcivescovo D. Martino de León y Cárdenas (1585-1655) al Cavalier Cosimo Fanzago celebre architetto e scultore11 il quale, nel vasto tentativo di abbellimento della Cattedrale di Palermo in veste barocca12, andava a sostituire l’antica e più semplice custodia realizzata in marmo da Antonello Gagini (1438-1536). Così stando anche alle antiche fonti fornite dal canonico Antonino Mongitore (1663-1743), che né da notizia come conferma della inestimabile preziosità del manufatto a misura della materia stimatissima a par dell’oro13.
Nominato arcivescovo di Palermo nel 1650, Martino de León y Cárdenas si era dimostrato particolarmente attento alle novità artistiche: fu lui, per esempio, fautore della campagna di attività (1631) che impresse al duomo di Pozzuoli un nuovo volto barocco14, appoggiato anche dal suo intimo amico, il viceré di Napoli Manuel de Acevedo y Zúñiga (1586-1653). Allo stesso modo, il medesimo diede avvio a moderne imprese monumentali e a una nuova concezione estetica nella Cattedrale di Palermo.
Sotto il suo mandato viene a cadere il giubileo del 1650 che, come sempre accadeva, rappresentava un’occasione unica di commissioni per gli artisti, molti dei quali proprio in vista di questa celebrazione erano coinvolti.
Originariamente ubicato nell’abside destra in prossimità del secondo transetto, un tempo destinata a mausoleo dei re normanni e svevi, il disegno del ciborio, realizzato da Cosimo Fanzago (1591-1678), prevedeva anche l’altare di supporto in marmi commessi fatto in Napoli per il Cavalier Cosimo15 e tra un gradino e l’altro della mensa si andava a inserire il tabernacolo sormontato dalla macchina architettonica del ciborio a due ordini e terminante con una cupola.
La data di commissione del ciborio a Fanzago, formalizzata da un regolare atto notarile, risale al 15 novembre 1651, opera per la quale Cárdenas devolveva la cifra di tremila scudi, di cui duemila «expendendi et erogandi in melioramentis et benefattis Altaris maioris seu ut vulgo dicitur dello Cappellone grande»16. Un’inedita relazione redatta in una data posteriore al 1652 ci permette di venir a conoscenza delle precise indicazioni rammentate dall’arcivescovo, esattamente lo stesso scrisse che: «la nave di questa contiene la cappella del Santissimo e perché non corrisponde alla magnificenza del cappellone sta in una custodia di legname moderata e povera, perché, quantunque ve ne sia una nella medesima chiesa d’argento di scudi settemila di valore, non è in forma che si potesse in essa ripor il Santissimo; ond’ho determinato per mia devotione farne far una di lapislazaro e bronz’indorato, tanto più che, essendo in questi lidi approdato un vascello di Smirne con molta quantità di detto lapis del migliore sia uscito da quelle miniere, ho tenuta congiontura di comprarne a buon prezzo abastanza, second’il parere degli esperti e d’un gioilliere c’ho fatto venir da Roma et altri da Firenze per fabricar detta custodia e di già è scors’un anno che vi lavorano coll’agiuto di diversi lavoranti della medesima professione et in meno d’un altro spero tenerla finita. La sodetta custodia è d’altezza palmi dieci otto, di larghezza nov’e mezo. Tiene otto colonne di palmi tre per ciascheduna, che in niun altra parte si vedrà la simile. La grandezz’è proportionata colla regola d’architettura. In tutt’il contenuto d’essa non v’è altro che lapis e bronz’indorato, artificiosamente lavorato e vagamente intagliato, presupponendomi far cos’insigne e singolare in tutta l’Italia»17.
Stimando la complessità del lavoro e la preziosità dei materiali impiegati tra oro e lapislazzuli, Cárdenas nominava ufficialmente, in qualità di intenditore, il padre oratoriano Giuseppe Gambacurta18 depositario e amministratore dell’ingente somma per la realizzazione dell’opera insieme al confratello padre Ponzio Valguarnera e successivamente nel 1652 a padre Giliberto Scuderi, dirigendo i pagamenti ai vari maestri orafi operanti in cattedrale e ai vari fornitori di lapislazzulo e di pezzi d’oro fuso, «bottoni et diversi pindali manigli agnusdei et un anello tutto di oro… per indorari la custodia»19, la stessa che ancora nel 1655 – secondo il rendiconto generale della contabilità dell’arcivescovo – «en este mi Arcobiscopal Palazio se està fabricando para el SS.mo Sacramento»20.
La custodia della cattedrale di Palermo è diretta erede del pensiero classicista e spesso dichiaratamente rigoroso di un Donato Bramante (1444-1514). L’artista bergamasco reinterpreta di lui il tempietto romano di San Pietro in Montorio realizzato nel 1502 per incarico dei reali di Spagna sul luogo in cui, secondo la tradizione, era stato martirizzato l’apostolo Pietro, traendone così in modo coerente i principi oggettivi tra norma e proporzione con le singole parti unita all’emulazione dei suoi effetti visivi, plastici e spaziali.
Come riferisce Antonino Mongitore21 per la custodia in particolare Fanzago avrebbe inviato a Palermo un modello ligneo. Tale manufatto, stando alle parole dell’erudito, fu collocato nel 1722, in occasione della solenne consacrazione, nella chiesa di Santa Elisabetta Regina al piano di Palazzo Reale, annessa al monastero delle monache del Terz’odine di San Francesco.
Le stesse caratteristiche e le stesse convinzioni caratterizzano anche un altro progetto della produzione dei tabernacoli in lapislazzuli: la custodia della chiesa delle monache benedettine di Santa Maria dell’Ammiraglio (Fig. 3).
Prima di affrontare la trattazione sistematica del ciborio benedettino, riteniamo opportuno evidenziare che la realizzazione di questa nuova opera costituì un’impresa impegnativa che le monache benedettine affrontarono dopo la ricostruzione tardo seicentesca dell’abside della chiesa, con l’esplicita volontà di dare un nuovo assetto allo spazio sacro attraverso l’osservanza dei nuovi precetti liturgici tridentini. La riconfigurazione della chiesa doveva essere quasi del tutto conclusa nel 1685 durante il governo della badessa Giuseppa Caterina del Castello, se il 28 ottobre dello stesso anno l’abside veniva aperta al pubblico dei fedeli «con sontuosa pompa», in occasione delle solennità di San Simone e delle «quarant’ore della Città»22. Il Mongitore affermava che entro quella data la cupola era stata già affrescata «dal celebre pennello di Antonino Grano»23 con la Gloria di San Benedetto e nei quattro pennacchi le figure dei Padri della Chiesa.
Esaminando l’altare è possibile avanzare alcune considerazioni in merito non soltanto alla tipologia architettonica, ma anche alla sua specifica corrispondenza iconografica e iconologica con i dettami dell’Ordine. Forse fu proprio Paolo Amato (1634-1714), architetto del Senato, a essere incaricato dalle benedettine a progettare il modello del ciborio per la loro chiesa nell’anno giubilare 1700; infatti, l’unica notizia certa riguardante l’opera è un esisto di pagamento in data ottobre 170124 il quale ci informa che entro quella data la custodia veniva completata e collocata definitivamente nell’abside. La presenza di Paolo Amato è stata accertata ulteriormente da alcuni documenti rinvenuti da G.B. Comandè uno dei quali riguardante un primo coinvolgimento dell’architetto per il disegno e per li diversi travagli del progetto dei partiti decorativi del nuovo presbiterio25.
Comandè, supportato dal documento del 1701, attribuiva la realizzazione di tutto l’arredo marmoreo a Paolo Amato, a differenza di Donald Garstang26 che, pur riconoscendogli l’idea progettuale, riscontrava rilevanti variazioni stilistiche tra le sue parti. Secondo quest’ultimo sarebbe da attribuirsi all’Amato sia il grande tabernacolo in lapislazzuli che l’ornato plastico della parete di fondo oltre i due pilastri con le statue di San Benedetto e di San Placido.
La paternità amatiana dell’apparato non è un’ipotesi del tutto peregrina, almeno sul piano concernente il disegno, come suggeriscono la ricercata elaborazione dei partiti decorativi e la qualità del modello compositivo non dissimile per taluni tratti al disegno degli apparati “Horti Esperidi” (1690) e del Catafalco eretto nella Cattedrale di Palermo per le ufficiali esequie del Delfino di Francia (1711). Le decorazioni del ciborio, nonostante presentino ancora un disegno proprio degli stilemi della tarda maniera, rilevano un’elaborazione raffinata e particolarmente articolata che in molti dettagli anticipa in modo deciso le più mature realizzazioni di Paolo Amato. Infatti, come ha evidenziato Maria Clara Ruggieri Tricoli27, il linguaggio dell’artista è andato evolvendo nel corso del tempo affondando le sue radici nella decorazione manierista di gusto vernacolare, della quale conserverà alcuni motivi anche nelle elaborazioni successive.
In questo progetto predominano forme e volumi orizzontali, come se l’autore volesse sfuggire dal verticalismo dei cibori tardo cinquecenteschi. La struttura compositiva appare, invece, ancora vincolata al modello del ciborio realizzato sul progetto di Cosimo Fanzago della Cattedrale di Palermo (1651) ma, rispetto al carattere marcatamente classico dell’opera fanzaghiana, il ciborio delle monache benedettine mostra un’esuberanza decorativa più aggiornata rispetto i canoni precedenti per l’efficacia del gioco illusorio e luministico sottolineata da Amato con un certo compiacimento.
La compagine architettonica rinserra la fuga prospettica con i triplici piani paralleli in una quadratura che va collegata alla successione degli archi dietro archi che danno la sensazione poetica di una spazialità sconfinata con un conseguente virtuale ingrandimento straordinario. Il gioco di scambi fra architettura reale ed effimera era senza dubbio altamente virtuosistico, basato sui travestimenti dello schema spaziale ma anche un esercizio del “saper guardare”. Qui subentra una limpida architettura, che si dilata in ampie esedre, una serena scansione di un ordine solenne di colonne e di volute sovrastato dalle immagini di Santi Benedettini, le balaustrate, le logge, infine la copertura a cupola. Il senso della costruzione della macchina liturgica era quello di prolungare lo sguardo fisico in quello immaginario. La chiesa abbraccia l’apparato, assorbendolo dentro di sé in modo che la contemplazione trapassi senza soluzione di continuità dal fisico al simbolico, dal reale possibile, dal basso – ove è collocato il tabernacolo – all’alto verso la cupola. In questo senso il tabernacolo si fa glorioso: come il Corpus Christi assorbito di vita divina diviene preludio di gloria, in tal modo la visione, quando si immerge nel lontano, si perfeziona e si concretizza.
Questa invenzione, che avverte l’esperienza del palcoscenico teatrale oltre che la trattazione scientifica collegata allo studio della geometria, della matematica, dell’ottica e della scenografia, presenta un trait-d’union molto stretto con i teatri scenici che compaiono nella Palermo barocca, ponendosi a corollario dei precedenti, quasi fossero un sottoinsieme del più vasto universo architettonico riconducibile a quell’unico perno della passione amatiana e che è emerso come costante leit-motiv di tutti gli apparati effimeri da lui progettati.
Agli inizi del XVIII secolo, sotto il secondo governo della Badessa Anna Colomba Aghilar (1700-1703, un ambizioso tabernacolo in lapislazzuli28 progettato dall’architetto Crocifero Giacomo Amato (1643-1732) avrebbe dovuto coronare l’altare maestro della distrutta chiesa delle monache benedettine di Santa Maria delle Vergini sotto il titolo di Sant’Andrea apostolo. L’opera è conosciuta attraverso alcuni disegni inseriti nei volumi dell’artista (Figg. 4 – 5 – 6), oggi custoditi nelle collezioni grafiche della Galleria di Palazzo Abatellis29.
Dell’elaborato si distinguono tre soluzioni grafiche ideate da Giacomo Amato per integrare l’imponente altare maggiore, ciascuna provvista di una monumentalità barocca decisamente estranea al panorama architettonico siciliano di quegli anni, con quattro colonnine disposte ai lati sotto una copertura a “squama di pesce”, presente in numerosi manufatti di matrice toscana, e affiancato dai Santi Benedetto e Scolastica, fondatori dell’Ordine, che diventano adoratori primari e guardiani celesti del Corpus Christi secondo lo schema iconografico della Trinità, e allo stesso tempo contribuiscono ad ampliare visivamente e concettualmente il ruolo di vertice assoluto del tabernacolo nello spazio interno della chiesa, traendo spunto dai precetti tridentini.
Come risulta da certi documenti conservati presso l’Archivio di Stato di Palermo, tra il 1697 e 1700, sotto il governo della badessa Anna Maria Castiglione, Giacomo Amato svolse il ruolo di architetto di fiducia all’interno del monastero benedettino30, occupandosi in particolare dell’edificazioni del nuovo dormitorio, del refettorio e delle spalliere lignee (andate perdute), la cui partitura architettonica era di indiscutibile somiglianza con quella del refettorio del Collegio Massimo dei Gesuiti di Palermo.
Simili caratteristiche compositive al tabernacolo della chiesa di Santa Maria delle Vergini, ma con efficaci variazioni, le ritroviamo nel tabernacolo in lapislazzuli della chiesa delle monache domenicane di Santa Maria della Pietà (Fig. 7), ricollocato alla fine del Settecento su un altare di ascendenza neoclassica. A parte quest’ultima eccezione, l’involucro del tabernacolo rimane comunque il medesimo, mentre l’adozione di nuove soluzioni compositive e strutturali altera completamente l’aspetto originario dell’altare. La sua realizzazione richiama coeve produzioni dell’architetto Giacomo Amato31, ripetendo l’efficace composizione in cui il ruolo determinante è giocato dalla peculiarità del materiale con cui è stato realizzato, contrasto fra marmo giallo di Castronovo, lapislazzuli e bronzo, che sembra fare riferimento a una più sofisticata concezione complessiva da parte di quest’ultimo.
L’esame formale e quello dei documenti sinora noti su questo tabernacolo non sono sufficienti per indentificarne con certezza l’ideatore, ma ci porta a riconoscerne un forte un legame con altre opere ideate dall’architetto crocifero verso la fine del XVII secolo.
Le tracce più cospicue dell’attività professionale di Giacomo Amato si riscontrano alla fine del Seicento: è, infatti, a questo periodo che risalgono gli incarichi più prestigiosi – la costruzione della chiesa delle monache carmelitane scalze delle Sante Anna e Teresa alla Kalsa e, soprattutto il completamento della chiesa di Santa Maria della Pietà – nonché le progettazioni di apparati effimeri per la solenne celebrazione delle Quarantore e gli interventi peritali svolti per committenze private32.
Tornando infine a seguire la traccia indiziaria di una diffusione di modelli e utilizzo principalmente di lapislazzuli, è possibile istituire proficui raffronti con l’altare maggiore della chiesa di Santa Chiara delle monache clarisse a Palermo (Fig. 8), un vero capolavoro dell’architetto Giovan Battista Vaccarini (1702-1768), soprattutto se pensato come superstite esempio di un’estesa rete di diffusione più che come scambio diretto.
Sin dagli inizi della sua attività di architetto, il disegno e la creazione di apparati liturgici dovette essere per il Vaccarini un’attività non secondaria rispetto a quella delle grandi architetture, così come precisa un passo dell’elogio dottorale, scritto dal protomedico Agostino Giuffrida33 in occasione della laurea nel 1736, nel quale si accenna ai magnifichi altari da lui ideati. I tabernacoli e gli altari, oltre all’importanza simbolica, assumono peraltro in molti casi tutti gli aspetti di vere e proprie architetture in scala (ciò avvenne ad esempio per molte delle custodie, realizzate in legno, visibili sistematicamente ancora oggi nelle chiese dell’Ordine Cappuccino in Sicilia).
I documenti di commissione dell’altare sono stati segnalati da Giulia Davì34 in uno studio sulla chiesa negli anni Ottanta del Novecento che indicavano Giovan Battista Vaccarini quale responsabile dell’opera e del modello reale del palio, quest’ultimo poi realizzato dall’argentiere romano Giuseppe Marchini che si sarebbe obbligato, inoltre, a fornire tutte quelle «pietre forte che in detto palio entraranno secondo il modello già dipinto bene et magistrabilis»35, così come si evince dalla stima redatta nel 1751 dall’ingegnere palermitano Francesco Ferrigno (1686-1766). Dai documenti si evincono i tempi di esecuzione dell’opera e le varie figure specializzate per la sua realizzazione. L’atto, stipulato per incarico di suor Maria Stefania Bellacera il 15 febbraio 1748 con Vaccarini prevedeva l’esecuzione dell’opera secondo il disegno allegato agli atti, purtroppo disperso, per un costo complessivo di 790 scudi. Nel quarto e quinto punto della scrittura notarile viene specificato che «li putti che vanno nel frontespizio debba farli fare in Roma con ogni diligenza e di tutta bellezza, et a sodisfatione a gusto di detta badessa» e che il «palio debba esser di commessi di lapislazzaro confacente al disegno, e debba farlo lavorare in Roma con ogni diligenza a paragone di qualsivoglia altro che sia in Roma e ponerci tutte le pietre forti, e belle a uso di commessi et il tutto d’ogni perfettione come sopra»36. Per questi angeli possono essere considerati come significativo termine di confronto le figure angeliche poste ai lati estremi, a sorreggere la mensa, dell’altare maggiore nel Duomo di Monreale, realizzati intorno al 1765 dall’argentiere romano Luigi Valadier (1726-1785). In queste opere la maniera dei due artisti, oramai evidentemente influenzati dal linguaggio berniniano, sembra quasi sovrapponibile.
Non sembra per nulla inverosimile, allo stato dei fatti sinora noti e delle corrispondenze cronologiche, pensare che il modello utilizzato per l’altare palermitano di Santa Chiara possa essere sopraggiunto da Roma a Palermo congiuntamente al Marchini e che nella sua ideazione possa avere avuto un ruolo considerevole Gaspare Serenario (1707-1759), cognato del Vaccarini, il quale terminava nel 1745 un lungo soggiorno romano durato una quindicina d’anni37.
L’accurato progetto dell’altare presenta una ricchezza di forme e di materiali usati nei gradini del postergale per la disposizione di una fantasmagorica quantità di candele e, particolarmente, nella ricchissima architettura della custodia coronata dall’ancor più articolata composizione del baldacchino contrastando con l’arcaicità delle ornamentazioni delle altre parti dell’altare; mentre, le delicate figure degli altri due putti posti ai lati del paliotto a urna, probabilmente ispirate all’analogo modello romano dell’altare di San Luigi Gonzaga ideato dal gesuita Andrea Pozzo (1642-1709), si distaccano quasi a esprimere una spazialità netta e diversa rispetto ai canoni architettonici che si erano imposti dopo il concilio tridentino.
La ricomposizione visiva del repertorio accumulato a Roma dal Vaccarini non è retrospettiva ma, grazie alle nuove concezioni su cui si fonda, si rivela in grado di rompere confini e appartenenze, e forse non è un caso che provengono da realtà geografiche più aperte agli scambi e meno vincolate a tradizioni forti abbiano maggiore facilità a conseguire esiti convincenti rispetto a chi era legato a centri di più consolidata egemonia di linguaggio. Ad ogni modo con questa accelerazione, da valutare nel suo complesso, vengono gettate le basi di un processo che punta con decisione alla creazione di un Barocco internazionale e a una stagione dove si afferma una Koiné europea di linguaggi architettonici.
All’interno di questo excursus merita un’attenzione diversa l’altare maggiore della chiesa di San Matteo al Cassaro (Fig. 9), ideato su disegno dell’architetto palermitano Emanuele Cardona (not. 1775-1820). Come hanno dimostrato i rinvenimenti documentari di Maria Clara Ruggieri Tricoli, il 13 settembre del 1798 il Procuratore della venerabile Compagnia dei Miseremini pagava 100 onze a magister Filippo Pinistri pro computo constructionis ex petris fortibus altaris Ven. Ecclesiae Sancti Matthei in Cassaro huius urbis, per atti del notaio Agatone Maria Serio38.
In questo tabernacolo si rintracciano influssi tardo cinquecenteschi, uno dei più fastosi del capoluogo siculo, la cui memoria è tramandata dalla celebre Guida di Gaspare Palermo.
Revisionando l’ampio corpus documentario relativo all’altare e valutando alcuni dati trascurati da studi pregressi, è possibile spostare credibilmente l’esecuzione dell’altare al marmorario Filippo Pinistri attivo nella fabbrica sin dal 1791 per un lavoro di marmi mischi nella zona del presbiterio. Dal 1798 fino al febbraio 1800 al maestro lapicida subentra l’architetto Emanuele Cardona per coordinare i lavori di marmorari, scultori e maestri orafi, il cui ingegno va associato al progetto del nuovo altare, contraddistinto da un tabernacolo di lapislazzuli con stemma dell’Agnello ed altri geroglifici … tutti di metallo dorato a caldo in oro zecchino,39 eseguito dall’orafo palermitano Antonio Barrile nell’ottobre del 1799.
A tal proposito è utile menzionare due manufatti senza dubbio debitori di questa invenzione: il pregevole tabernacolo in lapislazzuli, testé citato, della chiesa palermitana di Santa Chiara e, nel suo totale, l’altare maggiore della chiesa filippina di Sant’Ignazio martire all’Olivella progettato da Giuseppe Venanzio Marvuglia (1729-1814).
L’altare di San Matteo, la cui veste sembrerebbe l’esito di un compromesso, dovrebbe segnare quindi un momento di incontro-scontro tra Cardona e il linguaggio di Marvuglia. Ma, forse, dopo queste meditazioni, si può ipotizzare una ravvicinata risposta del Cardona a testimonianza della sua viva curiosità sperimentatrice. Nella chiesa di Sant’Ignazio martire Marvuglia, tra il 1786 e il 1801, seguiva l’esecuzione del suo progetto per l’altare maggiore; ma proprio in quegli stessi anni si stavano realizzando altri lavori all’interno della chiesa, che presentavano vari motivi decisamente rococò, a cominciare dalla Gloria di Giuseppe e Gaspare Firriolo (1786-90), derivante, con ogni evidenza, dalla decorazione realizzata da Ferdinando Fuga (1699-1782) per la chiesa di S. Apollinare a Roma, eseguita parallelamente alla Gloria della chiesa di San Matteo, compiuta dallo stesso autore, in cui il coronamento sormontato da personificazioni panneggiate in classica postura colma i fornici arcati scandiscono l’euritmica abside. E tuttavia, a differenza delle inflessioni concave e convesse che nell’altare di San Matteo rimette in questione scontate gerarchie, il nitido telaio trilitico dello schema a edicola ai piani paralleli in cui giacciono, rispettivamente, le colonne libere e la pala d’altare di fondo eseguita da Giuseppe Testa (1750-1816) rappresentante le Anime Purganti40, denotano una ricezione più orientata al singolo elemento che al sistema complessivo, improntato a una chiarezza ancora cinquecentesca; tutti caratteri di grande risonanza che introducono a Palermo un “bel composto” di concezione interamente rinnovata. In ogni caso, se si pensa a quanto sia vincolante la prassi dei modelli nel cambiare consolidati motivi architettonici negli altari palermitani – che costituiscono un insieme fortemente omogeneo e dai tempi di elaborazione lenti – tanto più risulterà evidente il gesto di allontanamento qui compiuto.
Alla fine del XVIII secolo l’impianto tradizionale del tabernacolo-ciborio venne formulato in una fantasiosa interpretazione nella chiesa di Santa Maria della Purificazione, terminata nel 1799 su progetto di Orazio Furetto (1714-1785).
Collocato sull’altare maggiore, il manufatto (Fig. 10), donato da Mons. Gioeni41, mostra una struttura ibrida in lapislazzuli e bronzo dorato, capace di assolvere la funzione di ciborio e allo stesso tempo di tabernacolo, espandendosi fino a formare un colonnato, con un fornice centrale più ampio coronato da una cupola perfettamente emiciclica, al di sotto della quale trova posto un tabernacolo in argento, ristabilendo in questo modo il connubbio ciborio-baldacchino-custodia. La custodia della chiesa palermitana di Santa Maria della Purificazione sembra richiamare soluzioni precedenti, la scansione della composizione esibisce numerose affinità con la custodia della Basilica di San Pietro in Vaticano realizzata da Gian Lorenzo Bernini (1598-1680). Come già notava Maurizio Vitella, in questa microarchitettura il rivestimento originale in lapislazzuli è oggi «quasi totalmente reintegrato con legni dipinti che ne ricordano il caratteristico colore, essendo stato spesso meta di furti»42.
Problematica risulta tuttora la provenienza del prezioso tabernacolo (Fig. 11), rivestito con inserti in lapislazzuli, diaspro agatato e ametista, esposto nella cosiddetta cappella Borremans del palazzo arcivescovile di Palermo, oggi sede del Museo Diocesano. Addossato alla mensa di un altare marmoreo proveniente dalla chiesa di San Giovanni l’Origlione di Palermo, il manufatto lascia intendere una forte affinità con la produzione palermitana della prima metà del XVIII secolo, come è possibile peraltro notare da alcune soluzioni formali. La documentazione particolarmente lacunosa non permette di individuare con esattezza le figure attive che avrebbero potuto prestare la loro opera, ma non è da escludere l’intervento di un architetto, non ancora identificato, che in quel frangente abbia fornito suggerimenti inerenti alla realizzazione del tabernacolo. A forma di tempietto a pianta centrale, sul tamburo della cupola trovano posto due figure angeliche e una gloria dello Spirito Santo, ma l’esistenza di due basi libere induce pensare a un numero maggiore di statue. L’attuale fisionomia è frutto, quasi certamente, di manomissioni che ne hanno sconvolto il suo aspetto originale non semplificando la lettura iconografica e quindi iconologica del tabernacolo.
Questi apparati liturgici, composti di pietre preziose, argento, cristallo di rocca43, se stimolati da fonti luminose naturali o artificiali, concorrevano ad accrescere l’aurea mistica della custodia mediante riflessi di luce, secondo un’estetica propriamente barocca di spettacolarizzazione e di coinvolgimento sensoriale dei fedeli. L’adozione di questi materiali non era scevra di significati e rimandi simbolici, talvolta rispondenti a precise indicazioni avanzate dalla stessa committenza ecclesiastica per esaltare e comunicare concetti cari alla Chiesa controriformata.
È il caso dei lapislazzuli, la cui tonalità oltremarina acquisiva una valenza cosmica e il richiamo alla fede; o come il caso dell’ametista che restituiva il colore del vino come allegoria del sangue di Cristo e allo stesso modo simbolo di umiltà, l’agata il rispetto, il diaspro l’Eterno Padre44, la madreperla il concetto di purezza e di rigenerazione. La profusione di questi materiali aveva inoltre il compito di trasfigurare formalmente l’immagine della Gerusalemme celeste descritta nell’Apocalisse giovannea: «il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. Le fondamenta delle mura della città sono adorne di ogni specie di pietre preziose»45.
Alla luce di questa esegesi il tabernacolo diventa simbolicamente una statio intermedia tra la realtà celeste e quella umana: le sacre specie che esso custodisce e che orienta all’adorazione sono il perpetuarsi dell’incarnazione del Figlio, suo Unigenito, realmente presente nel mondo attraverso il sacramento del suo corpo e del suo sangue. Il tabernacolo diventa così in maniera traslata un riflesso della Casa della Sapienza divina, giacchè come la Vergine concepì e diede al mondo la Sapienza divina così il tabernacolo diventa custodia di Cristo eucaristico, Sapienza incarnata.
Dunque il tabernacolo costituisce in sé una sorta di microcosmo, infatti, come abbiamo visto, pietre preziose rincorrono all’immagine della Gerusalemme celeste, diventando simbolo della trasmutazione dall’opaco al luminoso, dalle tenebre alla luce, dall’imperfezione alla perfezione. «Secondo la tradizione biblica, in ragione del suo carattere immutabile, la pietra rappresenta la saggezza»46. Crediamo quindi che non solo nella simbologia delle singole pietre sia stato ricercato un intrinseco valore metaforico, ma che la loro disposizione nelle membrature degli altari e nei tabernacoli che li completano sia frutto di un complesso rapporto enfatizzato dalla cultura barocca, dove non è solo l’azione liturgica a dare valore allo spazio dell’altare, ma è l’altare stesso che si carica di significati simbolici complessi nei quali si intrecciano concezioni spaziali, figurazioni sacre e i materiali impiegati, così ogni elemento ha un doppio ruolo simbolico e funzionale.
Dalla presente indagine affiora tutta la problematica che si riferisce allo studio di questo genere di realizzazioni artistiche nel contesto dell’arredo liturgico palermitano tra Cinquecento e Settecento. Una difficoltà spesso accresciuta dalla dispersione o dall’alterazione della facies originaria di questi manufatti, imputabile in primo luogo al trafugamento degli elementi di valore da cui erano composti; a circostanze storiche (vedi le soppressioni degli ordini religiosi, eventi bellici); e in infine, all’ammodernamento compreso dalla seconda metà del Settecento alla prima metà dell’Ottocento degli spazi liturgici. Questi altari furono realizzati con il contributo di personalità artistiche di primo piano e di maestranze orafe attive nei diversi settori delle arti applicate, e di committenti diversi della gerarchia ecclesiastica. Ma rispetto ad altre realtà geografiche, in primis la Toscana, per Palermo e il Mezzogiorno manca ancora una trattazione organica che possa far emergere in tutta la sua importanza, il ruolo centrale del tabernacolo-ciborio nel contesto delle arti decorative posteriori al Concilio di Trento.
- Precise indicazioni tratte in particolare dal capitolo XIII intitolato De tabernaculo sanctissimae eucharistiae si rinvengono nelle Instructionum Fabricae et Supellectilis ecclesiasticae (Milano 1577, pp. 22-24) curate da Carlo Borromeo (1538-1584), un particolarissimo trattato di architettura -nonostante il termine risulti fortemente inappropriato- le quali suggerivano in quel tempo le diverse modalità di allestire la struttura fisica del tabernacolo e gli specifici materiali da utilizzare (soprattutto lamine dorate, d’argento e bronzo), andando a integrare così quella vasta compagine delle riorganizzazioni ecclesiastiche post tridentine. (Primo illud in ecclesiis insignioribus, ubi potest, e laminis argenteis aut aeneis, iisdemque inauratis, aut e marmore pretiosiori, fieri decens est. Quod tabernaculi opus, polite elaboratum et apte beneque inter se compactum, piis item mysteriorum passionis Christi Domini imaginibus exculptum, et inaurato artificio certis locis, periti viri iudicio, decoratum, religiosi et venerandi ornatus formam exhibeat. Intrinsecus autem tabulis populeis circumamictum esse debet, vel aliis eiusmodi, ut ab humiditate, quae ex metalli marmorisve genere existit, sanctissima Eucharistia illo amictu omnino defendatur. Ubi tabernaculum eiusmodi non fiat, tunc e tabulis non nuceis, vel aliis, quae humiditatem gignunt, sed populeis aut similibus polite elaboratis, et religiosarum, ut supra, imaginum sculptura ornatis iisdemque inauratis, extruatur). Una posizione antitetica a quella del Borromeo comparve nel Cerimoniale episcoporum iussu Clementis VIII del 1600, dove si sarebbe discussa della necessità di separare il tabernacolo dall’altare maggiore e di dislocarlo in un’apposita cappella. Il dibattito sarebbe proseguito per tutto il Seicento senza però deliberare norme intransigenti o formule universalmente idonee, determinando scelte formali sempre originali e variegate. [↩]
- Cfr. M. Fagiolo Dell’Arco, M.L. Madonna, Il Teatro del Sole. La rifondazione di Palermo nel ‘500 e l’idea della città barocca, Roma 1981; M. Fagiolo Dell’Arco, L’illusione dell’infinito tra architettura e pittura: Pietro da Cortona, Baciccio, Pozzo, in M. Fagiolo dell’Arco, Roma Barocca. I protagonisti, gli spazi urbani, i grandi tempi, Roma 2013. [↩]
- Inizialmente il tabernacolo a forma di tempietto, con vano deputato alla conservazione delle Sacre Particole, discendeva dal propitiatorium altomedievale, in altre parole una custodia lignea o metallica generalmente mobile, munita di una serratura, come dispose il Concilio Lateranense del 1216. Cfr. G. Rapisarda, La custodia eucaristica, in Gli spazi della celebrazione rituale, Milano 1984, p. 98. Abitualmente, in età medievale, il propitiatorium prevedeva un ciborio (dal caldaico kib – arca – e urè o orion – luce-fuoco): un organismo sovrastante coperto a cupola e sorretto da colonne, a protezione dell’altare maggiore. Ispirato dal repertorio architettonico orientale, il ciborio idealizzava l’immagine della volta celeste, da qui la sua particolare conformazione a calotta sferica o poligonale, focalizzando altresì simbolicamente e scenograficamente la sua centralità nello spazio liturgico. Un’altra tipologia diffusasi fu quella della custodia a tempietto a pianta centrale articolato su diversi ordini, generalmente visibile in diversi punti dell’edificio ecclesiastico, compiendo simultaneamente sia la funzione di conservazione che di esposizione del Sacramento tramite un’edicola sovrastante. Composti con lamine di metallo pregiato (argento, rame, bronzo) e rivestiti da uno strato polimaterico di pietre e gemme preziose (diaspri, lapislazzuli, agate, madreperla, etc.), questi apparati liturgici divenivano dei veri e propri oggetti d’oreficeria a scala monumentale. Il modello più comune prevedeva l’ubicazione sull’altare maggiore in posizione dominante, tra i gradini del postergale o messo in risalto in strutture aggettanti e monumentali, al fine di evidenziare visivamente e concettualmente la presenza perpetua del Santissimo Sacramento. Nell’ambito dell’arredo liturgico destinato all’altare, era iniziata anche in Sicilia l’ideazione del monumentale ciborio, che riprendeva la struttura di un edificio architettonico di ridotte proporzioni con il tabernacolo sopra la mensa. [↩]
- C. Baronio. Annales ecclesiastici a Christo nato ad annum 1198, Roma 1588-1607. Le norme per la suppellettile ecclesiastica messe a punto dal cardinale Baronio suscitarono, ben presto, interesse e stimolarono una grande creatività nell’ambiente ecclesiastico; alcuni cardinali sostennero, infatti, interventi di recupero e di “ripristino” di edifici con il proposito, ancora evidente, di testimoniare la grandezza del cristianesimo primitivo. [↩]
- Cfr. A. Tricoli, ad vocem Tronchi Bartolomeo, in L. Sarullo, Dizionario degli artisti siciliani, vol. IV, Arti Decorative in Sicilia. Dizionario biografico, a cura di Maria Concetta Di Natale, Palermo 2014, p. 592. [↩]
- Cfr. G. Macaluso, Il crocifisso ritrovato, in «Ai nostri amici», marzo-aprile 1997, pp. 30-35. [↩]
- P. Pirri, Intagliatori gesuiti italiani dei secoli XVI e XVII, in «Archivium Historicum S.J.» n. 21. 1952, p. 8. [↩]
- V. Rosso, Descrittione di tutti i luoghi sacri della felice città di Palermo [↩]
- Sempre in Santa Maria Maggiore, costruita di fronte alla cappella Sistina è la cappella di Paolo V Borghese (1605-21), detta appunto “Paolina”, opera di Flaminio Ponzio di cui è famoso soprattutto l’altare in bronzo dorato con inserti di marmo e pietre dure realizzato da Girolamo Rainaldi e Pompeo Targone, che segna l’assorbimento di un gusto per la commistione di più materiali. [↩]
- Cfr. D. Frascarelli, Arte barocca e spazio liturgico nei luoghi di culto teatini, in «Regnum Dei» 2003, p. 243.Il padre Giovan Battista del Tufo, autore nel 1609 dell’Historia dell’ordine teatino attribuiva la magnifica custodia di San Paolo Maggiore agli “istessi maestri i quali hanno fatto il ricchissimo tabernacolo del Santissimo Sagramento, nella Patriarcale di San Giovanni Laterano, per ordine di Clemente VIII”. [↩]
- A. Mongitore, Notizie della cattedrale di Palermo, ms. del XVIII secolo ai segni QqE3, Biblioteca Comunale di Palermo, ff. 401-403. [↩]
- Per le vicende della cattedrale in età moderna M.R. Nobile, La cattedrale di Palermo tra XV e XVIII secolo, in Architettura: processualità e trasformazione, atti del convegno (Roma 24-27 novembre 1999) a cura di M. Caperna e G. Spagnesi, Roma, Bonsignori, 2002, pp. 371-376; sulla storia complessiva della fabbrica La Cattedrale di Palermo. Studi per l’ottavo centenario della fondazione, a cura di L. Urbani, Palermo 1993. [↩]
- A. Mongitore, Notizie della cattedrale…, ms. del XVIII secolo, f. 403. [↩]
- A. D’Ambrosio, R. Giamminelli, Il Duomo di Pozzuoli. Evoluzione del tempio augusteo in chiesa cristiana “episcopium sancti proculi”, Pozzuoli 2000, p. 22. [↩]
- L’imponente custodia in lapislazzuli è stata oggetto di un esauriente studio scientifico di Ciro D’Arpa, La committenza dell’arcivescovo Martino de Leon y Cardenas per la Cattedrale di Palermo (1650-1655): un intervento inedito dell’architetto Cosimo Fanzago, in «Palladio», n. 21, 1998, pp. 35-46, che su base documentaria ha contribuito a chiarirne le varie fasi di intervento. Si veda Appendice documentaria, doc. 1 (ASPa, Antichi notai, Giuseppe Tinti, vol. 3073, cc. 327r-328v, sub data 15 novembre 1651) trascritto da C. D’Arpa, p. 42. [↩]
- ASPa, Antichi notai, Giuseppe Tinti, vol. 3073, cc. 327r-328v, sub data 15 novembre 1651, trascritto da C. D’Arpa, La committenza…, 1998, p. 42. [↩]
- ASDPa, Capitolo, n. 31, cc. 85v-86r. Relazione ad sacra limina di Martino de Leon Cardenas, Arcivescovo dal 1650 al 1655. (Il documento è posteriore al 1652). Con riguardo il presente contributo si è avvalso di indicazioni e suggerimenti emersi in occasione di confronti e colloqui con il dott. Marcello Messina, da anni impegnato nella ricerca sui fondi dell’Archivio Diocesano di Palermo. [↩]
- Come già s’è detto sopra, il preposito e il procuratore della Congregazione in tale delicato incarico gestionale venivano affiancati dal deputato e dal protettore del monastero di Valverde e dal console pro-tempore della Nazione genovese di Palermo, ms. cit. 3 Qq D 3, c. 195v. [↩]
- Tali mandati sono tutti conservati nella Raccolta di bolle, brevi e documenti vari riguardanti il P. Gambacurta, Palermo, Biblioteca Comunale, ms. 3 Qq D 13. [↩]
- C. D’Arpa, La committenza…, 1998, nota 34, p. 42. [↩]
- A. Mongitore, Monasteri e conservatori, ms. del XVIII secolo ai segni QqE7, Biblioteca Comunale di Palermo, f. 402. [↩]
- G. B. Castellucci, Giornale Sacro palermitano, Palermo 1680, pp. 148-149; A. Mongitore, Monasteri…, ms. del XVIII secolo, f. 16. [↩]
- A. Mongitore, Monasteri…, ms. del XVIII secolo, f. 16. [↩]
- ASPa, Corporazioni religiose soppresse, Monastero della Martorana, vol. 807, f. 56r. ottobre 1701. [↩]
- Cfr. G. B. Comandè, Il Cappellone della Martorana, in «La Biga», anno III. nn. 8-12, 1948, p. 10. [↩]
- Cfr. D. Garstang, Use and Misure of Misure of Restoration: Santa Maria dell’Ammiraglio in Palermo, in «Apollo». 1985, p. 344-351. [↩]
- Cfr. M.C. Ruggieri Tricoli, Paolo Amato. La corona e il serpente, Palermo 1983. [↩]
- ASPa, Corporazioni religiose soppresse, Monastero delle Vergini, vol. 283, c. 60 v. 30 novembre XI Ind. 1702. Spese di chiesa e sacristia per onze cinquantasetti tt. 23.17 si fan buoni alla cassa sono le medesime spese dalla Reverenda Madre Abadessa dalli 31 gennaro 1702 per tutt’oggi […] et incluse in detta somma onze 7.23 per fare cinque palii ricamati et onze 45 per aggiunta della spesa fatta per il tabernacolo di lapislazzaro, argento et oro stante il resto essere fatto da elemosine d’alcune sorelle monache. [↩]
- Palermo, Gabinetto Disegni e Stampe della Galleria Regionale di Palazzo Abatellis, inv.n. 15753/dis. 99r (Fig. 4); inv.n. 15758/dis. 18 (Fig. 5); inv.n. 15758/dis. 19 (Fig. 6). Si veda M.C. Di Natale, I disegni di opere d’arte decorativa di Giacomo Amato per i monasteri di Palermo, in Giacomo Amato (1643-1732): I disegni di Palazzo Abatellis. Architettura, arredi e decorazione nella Sicilia Barocca, a cura di S. De Cavi, in corso di stampa. [↩]
- ASPa, Fondo dei notai defunti, Privitera Pietro, Stanza IV, vol. 1975 (minuta) c. 860, 20 luglio VII Ind. 1699. Il magister Joseph Pecoraro e il magister Francesco Serio fabri murari ricevono da suor Anna Maria Castiglione badessa del mon. delle Vergini di Palermo onze 58.26.10 per “attrattu e magisterio […] per havere fatto […] l’infrascritto servizzo nel detto ven. mon. e questo dalli 11 di maggio pp per tutti li 18 luglio di detto anno 1699”. Segue relazione (c. 861-865) delle spese, redatta da Giacomo Amato. [↩]
- Analizzando più adeguatamente la composizione del tabernacolo, ma soprattutto, alcuni dettagli decorativi, è possibile confermare la paternità dell’opera a Giacomo Amato. Il tabernacolo della chiesa di Santa Maria della Pietà mostra delle forti analogie con il coevo tabernacolo della distrutta chiesa di Santa Rosalia allo Stazzone del quale l’architetto crocifero avrebbe realizzato il disegno. Antonino Mongitore ci informa che: «in capo ha il cappellone con struttura a semicircolo: in esso si ha maestoso ciborio, o sia custodia di legno ricoperta d’oro, la grande bella custodia si alza nobilissima, terminata con imperiai corona, boccata d’oro: tutto fatto a disegno di Giacomo Amato fratello de’ Padri Crociferi». A. Mongitore, Memorie dei pittori, scultori, architetti, artefici in cera siciliani, ed. a cura di E. Natoli, Palermo 1977, p. 87. [↩]
- Cfr. M.S. Tusa, Architettura barocca a Palermo. Prospetti chiesastici di Giacomo Amato architetto, Venezia 1992. Per un maggiore approfondimento si veda Giacomo Amato (1643-1732) i disegni di Palazzo Abatellis. Architettura e decorazione nella Sicilia barocca, a cura di Sabina de Cavi in corso di stampa. [↩]
- A. Giuffrida, Elogio Dottorale con quale il protomedico Don Agostino Giuffrida, professore di filosofia superiore nello studio catanese, impone l’anello ed il berretto di dottore in filosofia e matematica a Don G. B. Vaccarini canonico secondario della chiesa della Cattedrale di Catania, Catania, Typis Trento 1736 (traduzione di F. Fichera, 1934). La dignità del luogo in cui mi trovo, vi mostra chiaramente quale difficoltà io abbia incontrato nel comporre questo discorso, illustrissimo Preside di quest’Almo Studio, Gran Cancelliere dello Studio di tutto il Siculo Regno, e Voi Padri ecccllentissimi nell’arte che professate. Attendete un discorso forbito, ma la vostra aspettazione sarà vana; e il mio dire impari al merito di costui che mi siede accanto, uomo sapiente in un consesso di dotti, e già celebre pei suoi meriti. Egli ha acquistato tanto sapere in Scienze Naturali e in Teologia quanto è possibile immaginare; lo attesta Palermo, che lo ammirò sommo in conferenze di Retorica e di Teologia, e per i suoi strumenti idraulici e pneumatici, per decreto del Senato, fu chiamato architetto primario. Lo attesta Roma, ove acquistò fama di egregio matematico per le esercitazioni in questa scienza, ivi fece ammirare un congegno con 49 bocche, delle quali alcune mandavan fuori vino, altre acqua per sei ore e poscia commutavano il loro ufficio. Per tali meriti, grande stima egli acquistò presso la Sacra Romana Chiesa, che per mezzo dei Cardinale Ottobono gli regalò un anello, pegno di protezione, e segno di onorificenza. Lo attesta la nostra Università, lo attestano i templi da lui eretti, che pare moltiplichino l’energia latente dell’anima, i disegni del Palazzo Municipale, i magnifici altari. Quando egli maneggia l’astrolabio pare che domini i cieli fino a Dio; se prende in mano il compasso non sappiamo dire se sia mirabile il principio o la fine del suo lavoro; se fa considerazioni sul mappamondo s’innalza con l’immaginazione al disopra delle terre e sa esser grande; se fa uso dell’archipensolo giunge a scrutare l’altezza delle scienze; se costruisce orologi, vince il tempo edace. Per ciò gli è gloriosissimo, e resterà immortale. E tu, o Vaccarini, dato che io non posso offrirti un elogio pari al tuo merito, tieni in mano un microscopio, che ingrandisce le cose minime, acciocchè possa ritenerti da me lodato degnamente. Quindi l’anello orni il tuo dito. Il berretto decori il tuo capo. Siano da te spianati libri, degni della tua interpretazione. Ti dò il bacio della pace, e l’amplesso della perfetta carità. Ti prego acciocchè voglia considerarti del nostro Studio presidio e decoro. Infine vivi felice e memore di noi. Sia che vivremo ancora, sia quando non saremo più. [↩]
- G. Davì, L’arredo liturgico nelle fonti, in La chiesa di Santa Chiara a Palermo. Ricerche e restauri, Palermo 1986, pp. 69-79. [↩]
- ASPa, Corporazioni religiose soppresse, Monastero di Santa Chiara, vol. 118, ff. 228, 230, 234. [↩]
- ASPa, Corporazioni religiose soppresse, Monastero di Santa Chiara, vol. 119, fascicolo I «Argenti nella chiesa del Monastero» ff. 57r-58v. [↩]
- Cfr. N. Marsalone, Il cavaliere Gaspare Serenario, pittore palermitano del Settecento, Palermo 1941, p. 55. [↩]
- ASPa, Fondo dei notai defunti, Agatone Serio, vol. 33931 (minuta) c. 421r, agosto 1797, trascritto da M.C. Ruggieri Tricoli in Cultura dell’antico e prassi della “rimodernazione”: Emanuele Cardona architetto dei Bianchi, in M.C. Ruggieri Tricoli, A. Badami, M. Carta, L’architettura degli oratori. Uno strumento ermeneutico per l’urbanistica palermitana, Palermo 1995, pp. 203-205. [↩]
- ASPa, Fondo dei notai defunti, Agatone Serio, vol. 18011 (minuta) cc. 83r-86r, 20 ottobre 1799, trascritto da M.C. Ruggieri Tricoli, L’architettura degli oratori…, 1995, p. 205. [↩]
- Cfr. P. Palazzotto, ad vocem Testa Giuseppe, in L. Sarullo, Dizionario degli artisti siciliani, vol. II, Pittura, a cura di M. A. Spadaro, Palermo 1993, pp. 324-325. [↩]
- A.A.P. (Archivio Albergo dei Poveri), volume di cautele per conto della R. fabrica da settembre 1793 per tutto agosto 1798, vol. 10 – busta 21 – c. 579 (5. 10. 1975), trascritto da M. Vitella in Il Real Albergo dei Poveri di Palermo, Napoli 1999, p. 133. [↩]
- M. Vitella, Il Real Albergo..., 1999, p. 81. [↩]
- L’impiego del cristallo di rocca, nonostante la natura fragile del materiale, si può ritrovare raramente in alcuni sportelli di tabernacolo, veri esempi raffinati di lavorazione a intaglio. Nel 1253 Al Tifāšī parla di un tabernacolo composto da due pezzi di cristallo di rocca. Cfr. C. Lamm, Mittelalteriche Gläser und Steinschnittarbeiten aus dem nahen Osten (Forschungen zur islamischen Kusnt, hrsg. von F. Sarre, V), Berlino 1929, p. 510. [↩]
- Cfr. G. Leone, a cura di, Pange lingua. Fonti visive calabresi per l’iconografia dell’Eucarestia, in Pange lingua. L’eucarestia in Calabria. Storia, Devozione, Arte, a cura di G. Leone, Catanzaro 2002, pp. 230-231. [↩]
- Cfr. G.B. Ladner, Il simbolismo paleocristiano. Dio, cosmo, uomo, Milano 2008, p. 164. [↩]
- Cfr. G. Heinz-Moh. Dizionario di Iconografia cristiana, Milano 1995, p. 221. [↩]