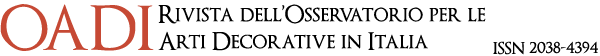Dora Thornton, A Rothschild Renaissance. Treasure from the Waddesdon Bequest, The British Museum Press, London 2015, 352 p., 300 ill. col.
Il volume, realizzato da Dora Thornton, curatrice del lascito Waddesdon al British Museum, nasce in occasione del nuovo allestimento museale di questa inestimabile raccolta di opere d’arte, inaugurato nel 2015.
Confluita nel 1898 nelle proprietà del museo londinese per volontà testamentaria del suo possessore, il barone Ferdinand Rothschild, la donazione consiste di quasi trecento opere d’arte medievali e rinascimentali, tra le quali spunta anche qualche falso ottocentesco, che, per precisa scelta del barone sono esposte tutte in un unica sala, sola collezione pervenuta al museo a non essere stata smembrata in diverse stanze.
Questi preziosissimi oggetti erano originariamente esposti nella residenza del celebre collezionista, il Waddesdon Manor, dove una stanza, la New Smoking Room, era stata appositamente allestita a questo scopo, divenendo una programmatica versione ottocentesca delle Schatzkammer dei principi rinascimentali, dove ogni pezzo è ricercato e strabiliante, piccolo ma nel contempo di grandissimo valore.
Dopo le prefazioni di Neil Mc Gregor, direttore del British Museum (p. 6) e di Lord Rotschild (p. 7), il libro si apre con i ringraziamenti e l’introduzione dell’autrice (pp. 8-11), la cui prima frase, «this book aims to stimulate close looking», esemplifica uno degli aspetti preponderanti della pubblicazione. Tale proposito è raggiunto egregiamente grazie alle splendide immagini a colori, che spesso sono in grado di mostrare dettagli minuti delle opere, altrimenti impossibili da cogliere. Le fotografie sono accompagnate da testi molto approfonditi, che per semplicità di lettura si dimostrano adatti a un pubblico ampio. L’analisi dei singoli pezzi è effettuata tenendo conto anche del significato che questi oggetti assumevano quando erano esposti nel Waddesdon Manor, il contesto in cui la collezione si è creata e la personale storia del suo possessore. Dopo l’introduzione si apre infatti una sezione dedicata ad analizzare in diversi paragrafi altrettanti aspetti legati alla collezione (pp. 12-71).
Sono innanzitutto fornite alcune informazioni sulle vicende private del barone Ferdinand e sulla storia della famiglia Rothschild (pp. 12-16), per poi analizzare la peculiare predisposizione dei suoi componenti, i più grandi collezionisti del xix secolo, all’acquisto di opere d’arte (pp. 16-20). Le pagine successive (pp. 20-26) riguardano la formazione del nucleo originario della collezione per mano del padre di Ferdinand Rothschild, il barone Anselm, che trasmetterà al figlio la serie di opere d’arte acquistate a Francoforte e a Vienna, nonché una straordinaria capacità nella scelta dei pezzi di maggior pregio tra quelli disponibili sul mercato. Questa dote si manifesterà in Ferdinand soprattutto nell’acquisto di gioielli, almeno quaranta esemplari tra 1874 e la sua morte nel 1898, di cui si parla nelle pagine dalla 26 alla 31. Alcuni di questi monili presentano tuttavia una serie di restauri ottocenteschi invasivi, altri sono stati integralmente realizzati da falsari; il tema della falsificazione sarà più volte ripreso all’interno del libro, presentandone i motivi propulsori, gli artefici e la difficoltà che ancor oggi si incontra nel distinguere un pezzo autentico da uno rimaneggiato o falso. Nelle pagine successive (pp. 31-39) si parla del luogo in cui la collezione era custodita ed esibita dal barone: la stanza che all’interno della sua residenza era sì adibita a fumare, ma nata con l’apposito scopo di contenere il suo tesoro di opere d’arte. L’ispirazione era sorta visitando le sale fumatori nelle dimore dei cugini Rothschild francesi, nelle quali era possibile ammirare le loro collezioni, e con i quali, come si deduce dalla corrispondenza del barone, egli era in continua competizione per l’acquisto dei pezzi più rari e preziosi. Ma Ferdinand sarà in grado di creare un ambiente del tutto nuovo, radicalmente diverso dal resto della casa, il cui allestimento fu completato nel 1896 dal restauratore di gioielli, nonché falsario, Alfred André. L’anno successivo, il barone pubblicherà una guida, The Red Book, nella quale la stanza è mostrata in una serie di fotografie, in cui sono visibili le diverse opere esposte in apposite vetrine e gli arredi ispirati al Rinascimento italiano. Da tali immagini si evince chiaramente quanta importanza fosse riservata a esporre la collezione in un unico ambiente, e al fatto che esso fosse specificamente allestito per essa, rifacendosi al concetto rinascimentale di Kunstkammer. L’aspetto della fruibilità della stanza è approfondito nelle pagine appena seguenti (pp. 40-42): il barone amava invitare gli amici per mostrare loro le nuove acquisizioni, e questo ha favorito la circolazione del suo gusto nello scegliere le opere d’arte, ma soprattutto nel modo di esporle.
La volontà di ricreare con le proprie collezioni l’idea di una Kunstkammer è comunque un fenomeno ampio, che coinvolge larga parte dei collezionisti europei dell’Ottocento. In particolare, in seguito alle guerre napoleoniche, e alla vittoria dell’Inghilterra, il collezionismo inglese si sviluppa moltissimo, con l’arrivo dal continente di tesori di ogni tipo, come esposto alle pagine 42-53. Il paragrafo successivo (pp. 53-59) è dedicato a spiegare le modalità attraverso cui il lascito Waddesdon è arrivato al British Museum: la volontà di Ferdinand Rothschild di evitare che la sua collezione potesse essere smembrata e che uscisse dalla Gran Bretagna, unita alla conoscenza del ruolo educativo delle grandi mostre pubbliche, lo avevano spinto a nominare la sorella Alice curatrice testamentaria, in modo che essa si assicurasse che la raccolta fosse esposta per intero nel museo, come in effetti è stato dal 1900 in poi.
Alle pagine 60-65 è presente un intervento di Rachel Boak, curatrice del Waddesdon Manor, riguardante il destino della residenza dopo la morte del barone. Alice Rothschild acquisterà nuove opere per riempire i vuoti lasciati nella sala fumatori dopo la donazione, e in seguito lascerà la dimora al figlio James, che nel 1957 la cederà al National Trust. Alle pagine 65-71 è invece esposto il nuovo allestimento della collezione al British Museum, che mira a ricreare l’impressione organica di una Schatzkammer, collocato all’interno della sala centrale, la quale precedentemente fungeva da biblioteca.
La corposa sezione che segue è dedicata alla trattazione monografica di alcune opere (pp. 72-325). Si tratta di 39 ampie schede nelle quali è possibile incontrare oggetti di lusso prodotti in una serie di contesti diversi, coprendo un arco cronologico che va dal xii al xix secolo. Le schede sono così suddivise: due dedicate a reliquiari, otto a manufatti in vetro o smaltati, tre a opere in ceramica, sei a microsculture in legno, sette riguardanti gioielli, undici su oggetti da mensa di vario tipo come coppe e brocche, e le ultime due riservate alla cosiddetta “Campana di Cellini” e allo scudo da parata noto come Scudo Ghisi.
Per ogni scheda sono presenti un’immagine d’insieme del pezzo e una serie di pregevoli fotografie dei dettagli e di altre opere poste a confronto. Nella didascalia della prima figura si trovano tutti i dati relativi a luogo di produzione, datazione, attribuzione, materiale, dimensioni e numero d’inventario. La bibliografia relativa all’opera non ha una sezione appositamente dedicata all’interno della scheda, ma è ricavabile dalle note, che si trovano alla fine del libro (pp. 326-346). Scorrendo le schede emerge la natura preziosa e ricercata di ogni pezzo, sul quale sono fornite informazioni esaustive, anche riguardo al contesto in cui esso è stato creato e quello in cui è arrivato al barone. É così dato modo ai lettori di scoprire altri nomi dei collezionisti dell’epoca, dei mercanti d’arte, dei restauratori e dei falsari, ovvero di tutti coloro che entravano a far parte come attori nel fenomeno del collezionismo ottocentesco.
Le opere presenti nel lascito sono di provenienza eterogenea, e alcuni colpiscono per fattura e materiali “esotici”: una lampada da moschea in vetro del tardo xiv secolo (pp. 104-107), una brocca ricavata da una conchiglia di nautilus (pp. 264-271), e una da una noce delle Seychelles (pp. 260-263). In grado di stupire per l’incredibile perizia con la quale sono realizzate sono anche le noci da preghiera, microsculture in legno prodotte nel Paesi Bassi nel xvi secolo, che, una volta aperte, rivelano scene di argomento sacro scolpite al loro interno (pp. 162-167 e pp. 168-171). Pezzi di spicco nella raccolta sono inoltre il Lyte Jewel, donato da Giacomo i d’Inghilterra (1603-1625) a Thomas Lyte, nella cui scheda sono narrate le implicazioni politiche e sociali riconducibili a questo dono (pp. 234-241), e la “Campana di Cellini” (pp. 310-317), creduta opera del celebre artista da Horace Walpole, noto collezionista che la possedeva prima di Ferdinand Rothschild, ma che già il barone riconosceva come opera di Wenzel Jamnitzer, orafo attivo nel Cinquecento a Norimberga.
Una buona parte della collezione è costituita da manufatti italiani, a cui sono dedicate cinque schede. Alle pagine 126-131 si parla della Deblín Cup, in vetro veneziano del tardo xv secolo, che prende il suo nome da un’iscrizione incisa sotto al piede, attestante il suo possesso da parte del signore moravo di Deblín. Prodotto negli stessi anni è anche un calice veneziano in vetro turchese, identificato come un oggetto legato alle nozze o al fidanzamento a causa della tematica amorosa presente nella decorazione (pp. 132-137). Manufatti vitrei che fingono pietre preziose e semipreziose erano largamente prodotti a quest’altezza cronologica a Venezia, e nel caso del vetro turchese l’ispirazione parte da antichi esemplari islamici, di cui uno, del 900 circa, è conservato da lungo tempo nel tesoro della basilica di San Marco. Una delle schede successive è dedicata a due vasi istoriati, realizzati in maiolica tra 1565 e 1571 nella bottega urbinate di Orazio Fontana (pp. 142-149). Appartenuti in precedenza a Horace Walpole, i vasi presentano entrambi piede e coperchio in bronzo dorato, aggiunte parigine del settimo decennio del xviii secolo, assenti invece nell’oggetto della scheda seguente (pp. 150-155), un vaso in maiolica del nono decennio del xvi secolo, opera della bottega Pattanazzi, anch’essa sita a Urbino. Da quest’ultima provengono inoltre due fiasche da pellegrino, oggetti da mensa che si rifanno ai contenitori utilizzati dai pellegrini per trasportare l’acqua (pp. 156-161). Una di esse era originariamente parte di un servizio da tavola realizzato per il duca di Ferrara Alfonso ii d’Este, l’altra presenta lo stemma dello spagnolo Fernando Ruiz de Castro, vicerè di Napoli dal 1599.
Altri due manufatti sono legati a maestranze italiane, ma prodotti in aree diverse: una coppa in cristallo di rocca del primo xvii secolo, realizzata a Praga nella bottega del milanese Ottavio Miseroni, che lì lavorava a servizio della corte imperiale (pp. 248-255), e lo scudo Ghisi, oggetto da parata con decorazioni classicheggianti, che un’iscrizione identifica come opera di Giorgio Ghisi, datata 1554 (pp. 318-325). Lo stile molto vicino a quello di Cornelis Floris colloca la produzione dello scudo ad Anversa, città in cui Ghisi aveva lavorato tra 1551 e 1555, ma, nonostante l’iscrizione, esso non può essere ricondotto in maniera sicura all’artista mantovano.
Gli oggetti presentati nelle prime tre schede sono tra tutti quelli di maggior valore: la prima (pp. 74-87) è dedicata al Reliquiario della Sacra Spina, uno dei pochi esempi superstiti di oreficeria con smalti en ronde-bosse, opera di artefici parigini degli anni intorno al 1400, probabilmente appartenuta a Jean de Berry. La scheda successiva parla di un oggetto parimenti inestimabile, il reliquiario a cassetta di Santa Valeria (pp. 88-95), realizzato nel 1170 circa da maestri limosini, con smalti champlevé. Infine la scheda alle pagine 96-103 tratta della Coppa Palmer, in vetro smaltato siriano o egiziano dei primi anni del xiii secolo, con montatura francese in argento dorato. In relazione a questo pezzo l’autrice ha il pregio di sollevare la questione relativa all’incontro di culture diverse, tipico per quanto riguarda i vetri islamici giunti nell’occidente cristiano, ma che in realtà coinvolge le manifatture di lusso medievali anche in altri ambiti, come quello tessile, dandoci modo di capire ancor oggi quanto un oggetto possa essere in grado di comunicare riguardo al contesto culturale in cui era prodotto, ma anche a quello in cui è stato utilizzato in epoche e luoghi diversi. Il lascito Waddesdon si connota nella sua interezza come una delle più preziose testimonianze in questo senso: inestimabile raccolta di opere d’arte e, nel contempo, prezioso manifesto del gusto vigente nel XIX secolo.